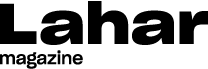Quel terzo giorno di ottobre, fece il suo ingresso in città un vento gelido proveniente da nord. Ad attenderlo non vi furono né grida di gioia né festose parate autunnali. Dalle finestre chiuse, protette dal riflesso di quel debole sole autunnale, si potevano percepire gli occhi turbati della gente. Occhi stanchi, spenti, come solo d’inverno. La rigidità di quel vento impensieriva la popolazione più di quanto già facessero gli avvenimenti di quegli ultimi mesi.
“Gli uomini uccello planano sulla città, guardandone dall’alto lo sfacelo. Il morbo, come il più democratico dei tiranni, colpisce chiunque: donne, vecchi, bambini. C’è chi crede che sia l’opera di Dio, irato dall’iniquità degli uomini, ad aver fatto piovere tale disgrazia sul mondo. C’è chi invece, come me, crede che la causa di quella tragedia sia l’uomo, e che l’odio che questi custodisce avidamente all’interno del proprio animo abbia distillato un veleno così potente, capace di diffondersi a macchia d’olio, incatramando con la sua viscosità tutto il genere umano. Un flagello la cui natura divina può solo essere immaginata, quasi sperata, per distoglierci dalla responsabilità di tutti quei corpi esangui”.
In quell’esatto punto della città, tuttavia, il vento era reso più timido dall’intricato dedalo delle viuzze acciottolate. Sopra a una porta di noce scuro, una figura leonina ondeggiava leggermente. Il cigolio dei cardini le dava una voce che poco conveniva alla sua naturale fierezza. Il fievole ruggito dell’insegna, cadenzando il cullare di quest’ultima, cantava il suo personale lamento, cedendo alla debole forza di quel vento al crepuscolo.
L’uomo fu attratto da quella melodia stridula, come i marinai che, a volte, sui mercantili del Mediterraneo, vengono rapiti dal dolce suono delle sirene, schiantandosi contro gli scogli.
“Nei pochi momenti di lucidità, quando le allucinazioni e la febbre alta lasciano brevemente spazio alla consapevolezza della mia condizione, riesco quasi a sentire l’odore che accompagna gli uomini uccello”.
Senza sforzo, aprì la pesante porta della locanda con un gesto lento, permettendo alla mano di trattenersi per qualche istante sul legno tiepido. La sala era flebilmente illuminata da una singola fonte di luce, un fuoco proveniente da un grosso camino di pietra posto sul lato destro della stanza. Non è difficile immaginare quali personaggi sedessero ai tavoli o appoggiassero i loro corpi stanchi al bancone, convinti di poter sciacquare via con un’alzata di gomito anni di sofferenze e fatiche: puttane mai state belle, delinquenti dediti a ignobili furterelli, vecchi marinai e mercanti dal viso incallito, gli uni dal vento, gli altri dall’avarizia. Il tetro vociare di quella triste combriccola si spezzò, lasciando al crepitio del fuoco l’infame compito di non lasciare la sala nel più completo e angosciante silenzio. L’uomo sentì una ventina di occhi spogliarlo, riducendolo a piccoli brandelli, ciascuno dei quali fu poi sottoposto ad un’ulteriore e minuziosa analisi. Incurante di quegli sguardi inquisitori e del silenzio che la sua presenza aveva creato, l’uomo chiuse con estrema cura la porta della locanda, si soffermò qualche secondo lasciando agli occhi il tempo di abituarsi all’oscurità e partì con decisione in direzione del bancone, dove l’oste, appoggiando meccanicamente una bottiglia verde sullo scaffale a fianco lui, manteneva stupito lo sguardo sulla strana figura che gli si avvicinava.
Non fu tanto il lungo vestito nero a sconcertarlo, ma la durezza della sua espressione, privata tuttavia degli occhi, resi invisibili da un’irreale sagoma scura. Il cappello, di un nero corvino, era ben affondato nel sul cranio del suo possessore e abilmente inclinato sulla fronte, cosicché la tesa di quest’ultimo coprisse la zona superiore del viso, rendendola di fatto inaccessibile a sguardi invadenti.
«Non è un posto per uno come lei, Padrepadre. Ci sono luoghi in cui uno straniero non dovrebbe ficcare il naso, specialmente in un tale periodo. Lo sa com’è la gente qua, fa meno fatica a tirare fuori il coltello che a fidarsi. Potrebbe anche essere contagioso per quel che…». Le parole gli si fermarono in gola, bloccate dall’inquietudine provocata dall’orribile maschera che l’uomo aveva appoggiato sul bancone. Il lungo naso ricurvo puntava l’oste in modo minaccioso e le cavità degli occhi brillavano di un’oscurità tangibile, quasi concreta. «Dio non m’interessa. Sono qui per la ragazza. Mi hanno detto che lei sa dov’è».
“Un misto di canfora, lavanda e aceto, mi entra prepotentemente nelle narici, regalandomi qualche secondo di sollievo dal tanfo degli escrementi sulle strade e dall’esalazioni del mio stesso corpo in putrefazione. L’uomo uccello è arrivato. Lo sento toccarmi con la punta morta del suo bastone, lo sento alzarmi le braccia e spostarmi i vestiti. Sento il suo disgusto penetrarmi le meningi. Percepisco il suo sguardo, carico di un giudizio che non voglio sentire, trapanarmi le interiora. Avverto, con estrema precisione, il momento esatto della tacita sentenza, l’attimo in cui i muscoli della sua faccia, seppur nascosti da quel terribile becco, si contraggono in un ghigno malato di soddisfazione.
Alzo lo sguardo, e per la prima volta conduco i miei occhi verso quelli dell’uomo di fronte a me. Niente. Non trovo nulla. Dietro i due vetrini rotondi della maschera vi è il vuoto, l’incommensurabile abisso dell’oscurità. Il miasma prodotto dall’unione delle erbe e degli escrementi viene sovrastato da un fetore ancora più forte e terribile. Un odore di morte”.
«Ah… sì. La ragazza…». L’oste s’interruppe brevemente, cercando di leggere sul volto dell’uomo un qualsiasi tipo di espressione. «La casa rossa, qui in Calle del Spezier… ma credo sia troppo tardi, la poveretta è spacciata».
L’uomo si alzò di scatto, con un movimento rapido che lasciava trasparire una sorta di febbrile impazienza. Dopodiché, con un’ incredibile flemma, ancor più inspiegabile considerata la smania di pochi secondi prima, si tolse il cappello, prese l’orribile maschera bianca e la indossò, facendo attenzione che i suoi lunghi capelli neri non si impigliassero al suo interno. Rimessosi il cappello alzò lo sguardo verso l’oste. Quest’ultimo, visibilmente paralizzato da una paura che non riusciva a spiegarsi, fu profondamente turbato dalla strana consapevolezza che sotto quella maschera il viso dell’uomo aveva perso tutta la sua rigidità e la sua bocca mostrava ora un sorriso terribile e meschino.
Le parole gli uscirono dalla bocca con un fremito proveniente da luoghi remoti e viscerali; un fremito gelido, come il vento del nord. «La prego, lasci queste supposizioni a chi di mestiere».