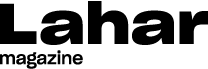Avevo quattordici anni e quattordici peli sulla faccia.
Rimini era bellissima nell’estate del millenovecentosessantasette e nell’aria suonavano le canzoni del Cantagiro.
Seduti sul muretto di fronte al dehor del bar Centrale, ci ubriacavamo gli occhi del Campari che le ricche vacanziere sorseggiavano nascoste sotto colorati cappelli di lino a tesa larga.
Eravamo certi che fossero forestiere, frequentavano ristoranti dove per fare il cameriere occorreva un diploma e facevano acquisti nelle boutiques dalle quali le nostre madri ci raccomandavano di stare lontani quando giocavamo a pallone. Eravamo certi, inoltre, che fossero bellissime.
La sera del venerdì ci ritrovavamo dietro il ristorante Garden Blue, Paolo portava il penny arancione di sua sorella e noi i quarantacinque giri che trovavamo a casa, sorseggiavamo gazzosa sfogliando il Tv Sorrisi e Canzoni vecchio di una settimana.
Quel posto non lo sceglievamo a caso. Quando tutti i clienti se n’erano andati, il proprietario del locale usciva dal retro con un piede e ci urlava “Dentro che si mangia”, così una volta apparecchiato per dieci, ci sedevamo a tavola con lui, il cuoco e i camerieri diplomati. Sapevamo che quel piatto ce lo saremmo guadagnati lavando i pavimenti e forse per questo, il proprietario, teneva a precisare ogni volta che ciò che stavamo mangiando non era “cibo di risacca”, per turisti.
La carne di quel pesce ci piaceva perché sapeva del nostro mare, delle barche dei nostri padri, delle reti tessute dalle nostre nonne. Ci piaceva perché non era mascherato con il pomodoro e le olive come amavano mangiarlo i turisti ma schietto e sincero come gli amici veri. Ci ricordava quanto era bella l’estate senza la scuola e le ragazze senza la calze. Era il nostro tesoro, eravamo noi, eravamo uomini.