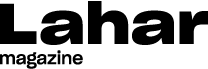Perdonami padre! Se sono stata una figlia disobbediente. Perdonami padre! Se ho lasciato la nostra casa e la nostra terra.
Col capo chino al suolo ti abbraccio le ginocchia.
Ho ancora l’odore del sangue sulle mani, l’odore di morte sulla pelle. Quanto tempo, quante lune si sono avvicendate sopra le nostre teste, padre. Ho ancora il ricordo vivo del corpo dell’uomo con cui sono scappata, indelebile, che mi ha reso il cuore duro come un dente di drago, mai più nulla vi nascerà, né amore, né pietà, né tristezza. Solo un’insanabile rabbia che mi sconvolge le notti, che mi fa sudare e mordere il lenzuolo e graffiarmi il petto. Perché ogni indumento, ogni vello che tocchi sia rosso di sangue. Sono fuggita per amore, per passione indomabile e mi sono ritrovata ad uccidere mio fratello che mi inseguiva. I brandelli del suo corpo abbandonati per strada, per fermare la tua corsa, ma non dimenticherò mai le tue grida come cento latrati all’unisono. Ancora echeggiano nelle mie orecchie. E i ricordi non mi abbandonano. Mi chiamavano la strega per le mie origini, nella terra dell’uomo mio marito. E mi evitavano e in mia presenza mi trattavano col rispetto che esige la paura. Esistevo per lui e grazie a lui e lo amavo di un amore disperato, come il moribondo ama la vita, come coloro che rinunciano a tutto per un’unica persona.
Ma lui amava il potere più dell’amore e scelse di abbandonarmi per una giovane erede al trono. Perché grazie a me lui ora aveva una posizione, era un eroe. Mi lasciava con i nostri due figli, ancora troppo piccoli per capire perché il padre non si sarebbe più presentato. E lì, mi si chiusero gli occhi e mi si aprì la mente, sbocciò come un crisantemo il furore della mia sventura. Io che avevo perso la patria, la casa, il marito e la reputazione, dovevo far perdere tutto anche al mio carnefice.
Ancora… ancora vedo il loro piccolo petto che respirava piano prima che il coltello affondasse nelle loro carni. Non hanno emesso un gemito, non vi fu alcun rumore se non il mio grido lacerante che oltrepassò i muri di casa e giunse all’orecchio di lui che intuì la catastrofe. E la sua giovane futura moglie, ignara e senza colpa, sarebbe morta anche lei. Con la sua bella corona in testa e con il suo bel mantello regale che cosparsi di veleno io stessa. Il bastardo doveva rimanere solo. Mentre le mani già pallide della fanciulla si accasciavano sul grembo, sembrava che pregasse la poveretta, il padre provò a soccorrerla e morì anche lui.
E Giasone allora ha visto le cose come le vedo io, per pochi attimi si è messo nei miei panni e non è riuscito a viverci che per pochi minuti. Il debole che voleva essere re. Si è ucciso, ma io no. Io sono ancora viva. E ho vagato con le Erinni nel cuore, con le budella che erano un groviglio di serpenti. Senza nessuno che mi accogliesse e nessuno che avesse il coraggio di uccidermi.
Hai idea di che coraggio ci è voluto per tornare nella Colchide che mi ha cresciuta e che ho abbandonato lasciando per strada una scia di sangue, del sangue di tuo figlio, del sangue di mio fratello?
Ora sta a te. Tua figlia Medea china il capo e chiede un posto dove fermarsi, perché ormai è vecchia, consumata dal fuoco del furore. Questo mucchietto di cenere chiede un’urna dove riposare. Altrimenti uccidimi ora, prima che possa guardarti ancora negli occhi.
di Nicola Andretta