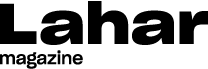Quella mattina spasimavo di vederti, per cominciare. Sentivo di non averti ringraziata a dovere per la domenica precedente, che corrispondeva con il mio compleanno. Quel giorno Bari era in festa per il suo patrono e per l’approdo nel porto della Amerigo Vespucci, nave-scuola della Marina Militare.
“Sarà aperta al pubblico” mi avevi comunicato qualche giorno prima, mentre come al solito non prestavamo attenzione al professore di turno. “Ci andiamo?”
Ti avevo detto di sì, sarebbe stata la prima occasione di incontro al di fuori delle fredde aule universitarie. Per come ti eri posta, poi, risultava complesso risponderti di no.
Mi ero presentato, la domenica ad ora di pranzo, come un totale sprovveduto. Non avevo considerato che centinaia di persone sarebbero accorse all’evento, e sarebbero salite sulla nave prima di noi allungando i tempi di attesa. Non avevo calcolato l’arsura ormai già estiva che ci avrebbe tolto il fiato e storditi, lo scirocco che ci avrebbe ingannati propinandoci coi suoi aliti leggeri un sollievo solo apparente. Non avevo così portato né acqua, né cappello, né ombrello. Il sole avrebbe bruciato la mia pelle chiara, e senza la crema avrei iniziato a sentire i brividi della febbre, un’estensione dell’inverno nella primavera ormai inoltrata. Soprattutto, non avevo immaginato che insieme a te sarebbero venuti anche il tuo ragazzo e le tue sorelle. Alla loro vista, avevo temuto di passare la giornata come quinto incomodo.
Non era stato così. Tu e loro, equipaggiati alla perfezione, avevate condiviso con me, durante le ore di coda prima della visita, tutto ciò che io avevo lasciato a casa. Soprattutto, mi avevate fatto sentire uno di voi. Neanche per un secondo avevo avuto la sensazione di reggere la candela, di essere un intruso. In un momento di silenzio avevo ascoltato il cicaleccio della folla che attendeva, osservato un gabbiano che volava raso acqua, inalato l’odore del sale marino e mi ero sentito felice, sul serio.
Sceso dalla nave ero corso in stazione per prendere il treno che mi avrebbe riportato a caso.
Così, quella mattina avevo voglia di incontrarti, ma tu non avevi dato segnali di vita, per proseguire. Non un messaggio, non una chiamata, nulla. Pensai, allora, che avrei potuto contattarti io. Avrei potuto scriverti: “Vieni in facoltà oggi?”, oppure: “Dove sei?”, ma mi trattenni. Era bastata una bella giornata passata insieme a sancire il mio diritto di disturbarti, di romperti le scatole? No, mi risposi. Io ti consideravo un’amica dopo quella esperienza, ma avevo la sicurezza che per te valesse lo stesso? No, così lasciai perdere. Mi rintanai a preparare un esame in una biblioteca e mi dimenticai della questione.
A mezzogiorno mi diressi verso l’aula in cui avrei seguito una lezione di lì a una mezz’ora. Allora apparisti, seduta a un tavolino a lato dell’ingresso dell’aula. Indossavi una tuta nera molto larga, scrutavi un quaderno con espressione corrucciata. Mi avvicinai a te, non mi notasti.
“Ciao” ti sibilai, temendo di disturbare la tua concentrazione. Alzasti la testa, sul tuo volto apparve un sorriso vero ma stentato, sembrava che qualcosa avesse succhiato dalle tue viscere la forza vitale che avevi manifestato domenica.
“Ciao” mi rispondesti in modo stentato.
“Posso sedermi? Ti disturbo?”
“No, affatto”.
Appena mi sistemai accanto a te, richiudesti il quaderno.
“Come stai?”
“Una merda. Mi è venuto il ciclo in treno. Sono arrivata qua e ho vomitato. Mi sento le gambe pesanti. Infatti adesso vado a casa di una mia amica che abita qua vicino, mi riprendo un attimo e poi torno a casa”.
Riponesti il quaderno nello zaino. Coraggio, pensai, fai il cavaliere. Non sta bene, guarda come è pallida, non è nelle condizioni di camminare, questa ti sviene in mezzo alla strada. Accompagnala, non succede nulla se perdi cinque o dieci minuti di spiegazione, dovesse venire meno almeno avrà qualcuno accanto a lei che le eviterà di sbattere la testa.
E invece no. No, perché chi ero io per importi la mia presenza se tu non me l’avevi chiesta? Sarei risultato inopportuno, mi avresti considerato una persona appiccicosa. Eppure, quando ti alzasti, prima di dirmi: “Ciao, ci vediamo domani” rimanesti in piedi pochi attimi esitante. Forse, a tua volta, temevi anche tu di disturbare me, aspettavi che fossi io a proporti di farti compagnia.
Cinque minuti dopo echeggiarono le sirene di un’ambulanza. Non mi presi nemmeno la briga di andare a verificare cosa fosse successo. Andai in bagno. Constatai che non ti avevo ringraziata per domenica. Che la mia innata insicurezza nelle relazioni umane, la costante sensazione di contare nulla per gli altri, di essere un “di troppo”, mi avevano impedito di contraccambiare tutte le gentilezze che avevo ricevuto il giorno del mio compleanno.
Vomitai. Mi rimase da sperare che non ti fosse successo nulla di troppo grave, e il desiderio di riuscire un giorno a tirare fuori di me, oltre allo sbratto, questo infame senso di colpa.