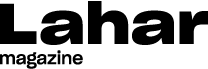Quando mamma Luciana abbracciò per la prima volta Alberto, appena venuto al mondo, scoppiò subito in lacrime. Perché? Perché proprio a lui? La vista di quel bambino aveva lasciato di sasso tutti i presenti per una particolare caratteristica dei suoi occhi, diversi tra loro, uno castano, uno azzurro. Nonna Adele imboccò l’uscita senza dire una parola, diretta verso la sala d’aspetto dove stava nonno Piero. Lo guardò dritto negli occhi, anche i suoi di colore diverso, uno castano, uno azzurro. “Va vedar cossa che te ghe combinà”, disse con fare burbero. Così Piero scoprì che quel suo difetto genetico, che nessuno dei suoi figli e nipoti aveva fino a quel momento manifestato, si era invece trasmesso proprio ad Alberto. Scoppiò a ridere, d’istinto. Poi guardando la nuora disse: “Luciana, spera chel gai ciapà soeo che questo da so nono”. E Luciana in cuor suo lo sperava davvero, perché in paese era cosa nota che Piero “nol ghea mia tutte e fassine al cuerto”. Una volta, tanto per dirne una, entrò in beghe con il Comune. Gli volevano espropriare un pezzo di terra per poter allargare una strada, e l’avrebbero anche pagato bene. “El campo ze mio e ghe fao queo che vujo mi”, disse al geometra comunale. Ovviamente, dovette cedere. Qualche tempo dopo però il sindaco capitò nell’osteria dove il nonno era solito trascorrere buona parte del suo tempo libero, l’Osteria Centrale. Non appena Piero vide l’automobile si alzò subito dalla sedia, si diresse verso la vettura appena parcheggiata, col sindaco ancora a bordo, tirò giù la patta dei pantaloni e fece pipì proprio sulla portiera posteriore. Chea volta che Piero ga pissà sua machina del sindaco. Che storia.
Quando Alberto entrò in quel lungo stanzone affollato di gente cominciò subito a guardarsi attorno. Quarto colloquio della settimana. Ultimo di una lunga serie. Ormai ci aveva fatto l’abitudine, a quei volti emaciati messi al muro, lungo il corridoio. Giusto il tempo di ascoltare qualche storia già sentita, far quattro parole con il responsabile del personale, poi via, all’aria aperta. Tutto finito, rapido e indolore. Sulla strada di casa si fermò alla vecchia Osteria Centrale, ora Shine Cafè. Era stato nonno Piero a portarlo in quel luogo per la prima volta, a colpi di un bianco par mi e na spuma pal bocia. Forse anche per questo tra quelle quattro mura Alberto si sentiva a casa, in quell’apoteosi di vera essenza umana, dove tutto era così rumoroso, dove il trare in vaca anche i discorsi più seri era arte da affinare con esperienza, bontà d’animo e spirito di osservazione. Parlava con i vecchi amici del nonno, con quelli del padre, con i suoi. In un teatrino di frasi fatte che qualche sapientone non avrebbe esitato a definire, con fare pomposo, uno spaccato della società veneta. E quella sera ne successe un’altra di memorabile. Qualcuno chiese al ragazzo come fosse andato il colloquio del pomeriggio, dando inizio a una lunga e travagliata conversazione, che si accese particolarmente quando il giovane, senza pensarci tanto, annunciò che se anche stavolta il colloquio non fosse andato a buon fine dal giorno seguente avrebbe rimesso in piedi la vecchia impresa agricola di famiglia, abbandonata dal padre e cessata con la morte del nonno. Che risate. E chi ci avrebbe mai creduto? Un giovane laureato in lingue che torna all’agricoltura. Figurarse. Così Alberto si alzò dalla sedia con lo stesso impeto di Piero, prese il primo tavolo libero che trovò a portata di mano e lo fece finire a gambe all’aria. Poi se ne andò, senza dire una parola, e tutti ammutolirono. Cominciarono a crederci, alla storia dei campi. E qualcuno, pensando a quegli occhi così particolari, disse le quattro celebri parole che avevano accompagnato Alberto per tutta la vita, litania eterna tra la nebbia della pianura.
Mato fa so nono.
di Nicolò Pettenuzzo