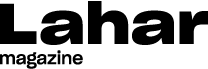Non aveva tutti i torti, Corto. “Gira strana gente” diceva “a quell’ora per la città”.
Erano più o meno le 12.30 di notte: l’ora dell’ultimo autobus che mi trascina in via Enrico Fermi e che porta via, per una quindicina di minuti, la notte del martedì di Torino.
Per me che vengo dalla campagna di Momello la città ha un odore sgradevole, simile a una puzza mai davvero insopportabile. Palazzi pieni di finestre, cartelli, cemento, vie strette e cieche; non immaginavo che potessero esistere tanti vicoli ciechi in una città, eppure Torino sembra avere così tante vie e nessuna vera uscita. Credo sia questa la sensazione più adatta a spiegare come ci si sente passando dalla vigna al marciapiede.
“Così prendi pure te lo stipendio”, diceva mamma, “come quello dei Mannini, che stanno sopra ai campi nostri”. “Come te, della vigna non ne voleva sapere”; mamma parlava sempre con voce calma.
Del figlio dei Mannini a Momello se ne parlava mica tanto bene: un ragazzotto svogliato, silenzioso, sulle sue, che di lavorare la campagna non gli era interessato mai.
Immagino dovesse sentirsi perso anche lui appena approdato qui, per le strade di Torino.
Su quell’autobus stavamo in due, tre con il conducente. L’altro era un tizio in giacca di pelle, talmente stretta da lasciar intravedere le forme del busto, jeans scuro e due stivali enormi.
Stava in piedi, appoggiato al palo, con un cappuccio che gli nascondeva occhi e capelli, e produceva un suono metallico, una specie di ciclink a ogni sobbalzo dell’autobus, dettato dalla presenza sulla sua giacca di una notevole quantità di spille, catene e borchie.
Aveva ragione Corto, per la città c’è strana gente a queste ore, al paese mica si trovano figuri così, mica c’è da aver paura per le strade di notte al paese, e anche ora che guardavo fuori dal finestrino vedevo un ponte, e sotto di questo c’era un fuoco dentro un bidone di metallo con attorno persone; pensai che doveva essere come diceva Corto: “mica è tutta pericolosa la città, ci sono le zone… sono posti differ…” ciclink, il mio filmino dei ricordi era stato interrotto dal suono metallico prodotto da quell’oscuro figuro in corrispondenza di una buca dell’asfalto. Fatto sta che quel ragazzo mi metteva sempre più paura e ogni maledetto ciclink mi faceva temere che avesse deciso di muovere verso di me.
“Sono posti differenti” – ripensavo alle parole di Corto – “in cui la gente mica si mischia, la gente per bene sta tutta da una parte, gli operai da un’altra e tutti quelli malmessi in un quart…” CICLINK
Una buca, ma che dico… una voragine, probabilmente, a giudicare dal suono. Sul sedile di fianco al mio un giornale aperto, leggo della Fiat 128, “car of the year 1970”; ciclink, altra buca, la figura non si muove.
Corto c’era stato un paio di settimane, a Torino, e ne era stato affascinato tanto che diceva che avrebbe mollato le bestie per andarci a vivere, prima o poi. Al solo pensiero io ero terrorizzato. Ora fuori dal finestrino si vedevano palazzi sempre più alti, sempre meno alberi, ai piani alti alcune luci ancora accese; ciclink, il suono del malvivente. L’autobus si era fermato e le porte si erano aperte lasciando salire un’uniforme blu, mentre la giacca di ferro e spille era scesa di corsa dall’autobus accompagnata da un assolo di ciclinkclunkclankclunch.
Notai che sul palo dove il ragazzo di ferro stringeva la mano c’erano delle impronte di sangue a forma di dita. Tutte e cinque le dita.
Io rimasi seduto fino alla fermata dopo, a fissare quella sagoma di mano, a pensare che probabilmente avevo schivato un appuntamento con la morte di qualche secondo e che se mai fossi uscito vivo da quella notte sarei tornato presto al paese per raccontarlo a tutti, e che avrei potuto raccontare anche io la mia versione, che Corto l’aveva vista la città, che la sapeva lunga, ma che io ero stato in trincea veramente e che avevo visto il pericolo dritto in faccia.
La fermata dopo era la mia, la prima notte l’avrei passata a casa di Mannini: i genitori avevano insistito con mamma perché stessi dal figlio fino a che non mi fossi sistemato.
Si trattava di un ultimo sforzo nella notte di Torino, dalla fermata alla casa del mio compaesano, con cui avrei subito parlato di quanto fosse bello il paese di Momello e di quanto sicuramente gli mancava, visto che erano un paio di anni che se ne era andato.
La riga bianca del marciapiede sembrava sempre la stessa, e il porfido e il catrame avevano ancora un odore acre lungo la strada; la luce della notte nella città era gialla, ma di un giallo opaco, sbiadito dai fumi. Arrivai al numero 35 di quella strada grigia, che terminava a un tiro di sputo in un vicolo cieco, anche questa. Una porta di ferro sporca e un campanello con un nome sbiadito che diceva Mannini: così, desideroso che la notte finisse, suonai il campanello.
Una voce distante chiese: “chi è?”
“Cerco Mannini, è in casa?”
Dall’altro lato della porta si sentiva solo un rumore di passi pesanti, accompagnati da un inconfondibile suono: ciclink.