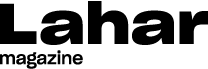La nostra era l’ultima casa del paese. Poi c’era un prato su cui non si poteva giocare a niente perché altrimenti il fieno veniva su male. Poi c’erano la diga e le turbine dell’Enel. Poi c’era il confine, e la Svizzera. La nostra camera era l’unica esposta a nord e quindi faceva freddo e quindi le persiane dovevamo tenerle chiuse. Però quando arrivava marzo e la luce si spalmava – sempre più a lungo, sempre più oltre, come il piacere che ti dà una mano calda dove la vorresti – noi passavamo ore a guardare l’orizzonte, girando sigarette tossiche con la carta dei quaderni Fabriano e l’erba che trovavamo nei boschi. Un orizzonte diverso da quello dei film. Il nostro era stretto e isoscele. Era lo spazio che montagne a perenne rischio frana ci lasciavano. Se avevi la fortuna di una giornata senza nuvole, quell’orizzonte passava dall’azzurro al colore dei non-ti-scordar-di-me, al blu di prussia sempre temperato, al nero totale. Anche di notte, però, potevi scorgere la cima innevata del ghiacciaio, illuminata dalla luna, più visibile del neon della farmacia di turno. Se c’era una nuvola, anche minuscola, noi sapevano che il giorno dopo sarebbe stata pioggia. Anche il nostro modo di pensare era fatto così. Pieno di angoli acuti. Abituato ai silenzi. Incapace di spingersi oltre il domani. Sapevamo che proprio dove le due montagne si intersecavano, lassù, non c’era nulla se non una ex fabbrica di scope, poi diventata un hotel tre stelle qualità superiore, poi abbandonato perché nessuno voleva dormire dove l’ombra arrivava subito, poi diventato il posto dove noi ragazzi senza dopodomani andavamo a giocare a fare gli anarchici, i satanisti, gli amanti.
di Giulia Mietta