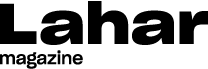La bicicletta è sempre esistita nella mia vita. Mai però come ‘la bicicletta’, ma sempre come ‘la bici’.
Il primo desiderio, da piccolo, era proprio quello di imparare ad andare ‘in bici’.
Sono nato in un piccolo paese della campagna romagnola, a venti km dalla “città”, Ravenna. Era il 1968 e, anche se può sembrar strano, visto che in fondo eravamo già agli albori dei ’70, era ancora molto chiara la differenza tra nascere e crescere in campagna ed in città. Ed io, a sette anni (quando cioè i miei genitori si trasferirono in città), me ne accorsi. C’era un modo diverso di affrontare le giornate, la scuola, i rapporti amicali. C’era un modo diverso di giocare: io fremevo per il calcio, che per me significava interminabili partite nelle aie, su terra o ghiaino, che cominciavano dopo pranzo e terminavano quando le madri ci chiamavano a casa per la cena. Quelle grida, quei richiami, erano la nostra preoccupazione, perché puntualmente le ginocchia erano scorticate, i pantaloni strappati, le magliette sporche. In città, invece, tutto rientrò nelle regole: il calcio per me divenne stare in una squadra, con le divise, le scapette bullonate, l’arbitro e l’allenatore.
Ma questa è un’altra storia.

(nella foto, sono io a tre anni, nel 1971, con la mia prima bici e un improvvisato bambolotto come passeggero! Non sono visibili, ma ci sono montate le ruotine)
La costante che accordava città e campagna era proprio l’uso della bici. A tre anni –come tutti i miei amichetti- fremevo per imparare ad andare in bici e sapevo che avrei dovuto affrontare la “ruotine” che a tutti noi piccoli toccava, ossia l’inserimento di due mini-ruote che venivano inserite posteriormente e ci permettevano di restare in equilibrio. Poi, dopo giorni di pratica, finalmente si era pronti per la grande prova: genitori e nonni in cortile a far da spettatori e tu ai margini della scena, pronto ad entrarvi come assoluto protagonista. Ecco che, improvvisamente, staccavi i piedi da terra e attraversavi l’aia o il cortile pedalando. Il miracolo si compiva! Sembrava di librarsi nell’aria. Ci si sentiva completi, fieri, consapevoli di aver superato il rito delle ruotine ed aver iniziato, in punta di piedi, ad entrare nel mondo dei grandi, cioè di quelli che andavano in bici. Il passaggio successivo sarebbe stato quello di andare in giro per strada, come i “grandi”.
Ricordo un particolare curioso, a proposito dei “grandi” che andavano in bici: il nonno, e come lui altri anziani del paese, pedalava con i piedi in fuori, poggiati sui pedali ma tenendoli “a papera”: Non ho mai capito il motivo, e ahimè non glielo ho mai chiesto!
Tutta l’infanzia è stata in bici: a scuola si andava in bici, a catechismo in bici, ad allenamento in bici. La città si muoveva (e si muove tuttora) sulla bici. Le scuole medie e i primi anni di liceo, prima dell’acquisto del motorino (altro passo verso l’autonomia dalla gestione genitoriale), furono tutti rigorosamente in bici. Ricordo che, all’uscita della scuola, con altri amici andavamo in bici davanti alle altre scuole, per incontrare potenziali ”morose”. I primi corteggiamenti erano proprio nell’accompagnare in bici la ragazzina a casa: lei sulla sua, noi maschietti sulle nostre. I più fortunati, a volte, le caricavano “sul cannone” della bici, e quando questo succedeva era un passo decisivo nella conquista amorosa.
La prima ora di lezione, per i cinque anni di liceo, era alle 7.50 del mattino: nel tempo ero riuscito ad arrivare a scuola in sei minuti, rigorosamente cronometrati, mattino dopo mattino. Ogni mattino inforcavo la bici e scattava il cronometro. Così per quasi cinque anni. Era un dato importante, perché mi permetteva di svegliarmi più tardi, un po’ come correre un personale record che mi permettesse di guadagnare qualche minuto di sonno in più. In quinta riuscivo a mettere la sveglia alle 7.25 ed entrare puntuale a scuola… quando ci andavo…!
Poi vennero gli anni dell’università a Bologna dove, rigorosamente, andavo a lezione in bici!
Nel frattempo era entrato nella mia vita il teatro, che dopo l’università divenne una professione. Cominciai a girovagare per l’Italia e per alcuni anni la bici rimase in garage. Ma il destino delle due ruote, per me che ero praticamente nato sulle due ruote, entrò impetuoso anche a teatro. Per tre anni (dal 2003 al 2006) ho lavorato sui temi della Resistenza raccogliendo centinaia di storie partigiane e scrivendo (e portando in scena) due spettacoli: Napoleone. Storie di partigiani e 44. Il coraggio della scelta.

Enrico Caravita, uno degli interpreti di “Napoleone. Storie di partigiani”; come si può vedere tieni tra le mani la preziosa bici “partigiana”.
Napoleone raccontava le vicende partigiane di due giovani che, avendo perso la memoria, pedalavano per le strade della Romagna alla ricerca di cippi o lapidi che testimoniassero avvenimenti legati alla Resistenza. La mia terra è stata drammatica testimone di quei terribili anni di guerra. I segni sono tuttora visibili lungo le strade di campagna, o sui muri delle città: cippi, lapidi, mazzi di fiori che raccontano di fucilazioni, impiccagioni, drammatiche e luttuose vicende di resistenti e partigiani che hanno pagato con la vita le loro azioni e i loro ideali.
In 44 invece le storie raccontate riguardano le staffette partigiane. Erano ragazze, alcune giovanissime, che militavano nella resistenza partigiana nelle mie zone. I loro compiti erano di collegamento fra i vari distaccamenti partigiani e militari, l’approvvigionamento di viveri, il trasporto di armi, medicinali, informazioni. La loro peculiarità era proprio la bicicletta, che usavano per spostarsi. Giravano generalmente in due: una avanti, “a far strada” (cioè controllare che non ci fossero nemici o posti di blocco) e una dietro, qualche centinaio di metri. La seconda, quella dietro, era quella con il materiale da consegnare, tenuto spesso nelle “sporte” (borse con
manico di paglia intrecciata, spesso rimaneggiate con doppiofondo); in caso di pericolo la prima staffetta avvisava la seconda con segnali prestabiliti così che questa potesse cambiare strada. Ci sono storie avvincenti di queste eroiche ragazze che hanno rischiato più volte la vita per gli ideali di libertà e democrazia.

(una delle biciclette usate per gli spettacoli Napoleone e 44)
Alcune di queste donne sono state catturate, torturate e uccise dai nazi-fascisti. Nello spettacolo raccontavamo queste drammatiche vicende, spiegando gli stratagemmi e le condizioni con cui le staffette partigiane operavano.
Tempo dopo la danzatrice e coreografa Carla Rizzu rimase affascinata dal tema e costruì un lavoro di teatro-danza proprio partendo da una delle storie raccontate nello spettacolo, partendo dalla vicenda di due eroiche staffette, Candida Bondi e Ines Bedeschi, che vennero catturate e barbaramente uccise. Nacque lo spettacolo Nome di battaglia, un omaggio a queste due esemplari figure che, anche tra loro, si conoscevano attraverso un nome fittizio, un nome di battaglia, per non fornire alcuna informazione in caso di cattura.

Carla Rizzu e Claudia Bosco in “Nome di battaglia”; a sinistra le due danzatrici-staffette con le biciclette e a destra con le “sporte”.
Poi, per caso, improvvisamente, è arrivata Alfonsina. Alfonsina Morini, classe 1891, maritata Strada, nativa di Fossamarcia, una piccola frazione della bassa Emilia, pochi kilometri da Castenaso, provincia di Bologna.
E’ stata Patrizia Bollini, attrice con cui avevo collaborato in un precedente spettacolo (Le sorelle Misericordia) a contattarmi: “Euge – mi dice al telefono- scriveresti un monologo per me? Ho del materiale sulle donne e lo sport… alcune figure particolari, interessanti… te lo mando se vuoi”. Così vengo a conoscenza della figura di Alfonsina. Mi infiammo immediatamente. Cerco altro materiale e trovo una sua biografia scritta dal giornalista Paolo Facchinetti, e nel giro di qualche giorno sono a casa sua con Patrizia, a chiaccherare di Alfonsina.
Io venivo, come ho detto, da esperienze teatrali in cui la bici era uno dei protagonisti in scena, ma questa volta era diverso: anima corpo e bici erano una cosa sola. Pensare e parlare di lei è imprescindibile da pensare e parlare della bicicletta. Fuse insieme, donna e ruote, con una determinazione e una volontà degne dell’acciaio. E poi le sue parole, anzi, i suoi silenzi: Alfonsina, con la sua vita e le sue imprese, diventa paladina di un movimento sportivo –e non solo- al femminile, senza però parlare mai né di ‘femminile’ né di “femminismo”. Agisce, non parla. Vuole correre, e corre.

(Alfonsina in una cartolina autografa; era uso che, durante il Giro, i ciclisti le regalassero ai tifosi che si assiepavano)
E nasce “Finisce per A. Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù””, un testo e uno spettacolo interpretato da Patrizia Bollini e diretto da Gabriele Tesauri.
Alfonsina Morini in Strada, ciclista. A dirla così potrebbe sembrare il tipico personaggio di una commedia di Achille Campanile. In realtà del brillante commediografo e umorista Alfonsina ne fu coeva e, chissà, magari si ritrovarono perfino nello stesso teatro, ma con sorte e destinazione ben diversa: Alfonsina infatti correva in bicicletta, anche nei teatri. E morì, gioco appunto di una sorte alla Campanile, morì proprio sulla strada, in sella ad una due ruote sì, ma… una motocicletta!
Ma la sua vita fu tutt’altro che uno scherzo: figlia di una poverissima famiglia (15 tra sorelle fratelli nipoti e zii), si innamorò giovanissima della bicicletta che il babbo usava per andare a cercar lavoro. E con quella iniziò a pedalare per le strade tra Castenaso e Molinella, provincia di Bologna. Poi la passione per le due ruote la portò due volte a partecipare al Giro di Lombardia e, finalmente, nel 1924, al Giro d’Italia. Naturalmente maschile. Sembra che la iscrissero per avere un fenomeno pubblicitario, ma ufficialmente, alla punzonatura di partenza a Milano, venne presentata come Alfonsin Strada. Quella letterina finale mancante, quella ‘A’ smarrita, non si è mai scoperto se sia stato un errore grafico o una voluta scelta, quasi un timore sotteso a far correre con gli uomini una donna. Da qui il titolo del testo, appunto, come se Alfonsina stesse a ribadire che “…il mio nome finisce per A!”.
Le donne stavano con le gonne mentre Alfonsina metteva i pantaloncini. E con le ginocchia scoperte scandalizzò i 13 mila kilometri del Giro, correndo una vera e propria Via Crucis di 12 tappe: strade sterrate, cadute, nebbia, vento, pioggia, neve, Alfonsina non si fece proprio mancare nulla a quel Giro, anche il fatto di essere una pioniera dello sport al femminile. Anche con un manico di scopa legato con dello spago, a far da manubrio! E arrivò al termine del Giro, fuori tempo massimo ma arrivò. E non smise di correre, lanciandosi nella ruota della morte, nelle gare sui rulli (vari i record di velocità che riuscì a stimare), che la portarono sui palcoscenici di tutta Europa.
Salutò i pedoni nel 1959 accasciandosi a fianco della sua fiammante Guzzi 500 (vista l’età aveva abbandonato i pedali), di fronte alla bottega di riparazioni per biciclette che aveva aperto a Milano, piccolo rifugio dei tantissimi gatti che amava e dei tanti ragazzini che la circondavano e ai quali insegnava i segreti delle due ruote. Ma la nostra eroina era partita da sola per il suo lungo viaggio sulle due ruote, e da sola aveva terminato la corsa della sua vita. Un rimpianto, forse l’unico, a fianco della lunga solitudine, era una frase che spesso, negli ultimi anni in bottega, pronunciava sottovoce, guardando i ragazzini che affollavano la sua bottega: “Chissà se qualcuno… se qualcuno mi chiamasse… mamma”.
Una donna in bicicletta. Una donna che corre in bicicletta. Facile a dirsi, ma meno facile 88 anni fa, precisamente nel 1924, quando Alfonsina Strada, si iscrive e partecipa al Giro d’Italia. Prima ed unica donna a farlo, in quel tempo. Uno scandalo, per quella “corriditrice” che tutti credevano volesse sfidare gli uomini, ‘i maschi’. Ma Alfonsina voleva solo volare sulle ruote, correre nel vento, arrampicarsi per le montagne. E “il diavolo in gonnella” lo fece. Per tutta la vita, perché per tutta la vita la sua grande passione per le due ruote continuò.

Quando Patrizia mi ha parlato, per la prima volta di Alfonsina, le ho visto gli occhi luccicare. Io sono un uomo, un ‘maschio’, e credo che non potrò mai capire fino in fondo cosa possa significare per una donna, specie in quegli anni, affrontare la società –seppur sportiva- dei ‘maschi’. E così ho provato a salire anche io sulla bicicletta delle parole, e a ripercorrere, insieme ad Alfonsina, il suo Giro d’Italia e le sue successive mirabolanti imprese che ne fecero un’eroina del tempo. E ho provato ad immaginare questa ragazza che, nella solitudine delle salite o nelle lunghe traversate delle pianure afose sulle strade sterrate, pedalasse e parlasse… parlasse per non sentire la fatica, per non ascoltare chi la osteggiava, per non smollare mai… ecco, avviasse un dialogo con Gesù. Si tratta di un Gesù nei ricordi del Catechismo, un Gesù che sta nel Cielo e nella Terra, nelle cose che la circondano, nel vento che le sbatte contro, nella pioggia che le serra gli occhi, nel sole che la acceca… un Gesù che, come lei, è stato condannato dalla legge dei ‘maschi’. Non si tratta di una preghiera, ma di un vero e proprio soliloquio, parole dette nella mente, raccolte nelle gambe e animate dal respiro, affaticato ma felice, di chi non si è mai voluto arrendere.
Patrizia Bollini dà voce e corpo a questa incredibile pioniera dello sport femminile, meno nota della coetanea Ondina Valla, ma altrettanto importante nella storia dell’emancipazione sportiva –e sociale- delle Donne.

Patrizia Bollini in due momenti di “Finisce per A” (foto di Achille le Pera)
Per chiudere.
Vivo a Ravenna, una città che si attraversa in dieci minuti, in bici. In casa, tra me e la mia famiglia (4 persone), abbiamo 6 bici. Io d’inverno mi faccio vincere dalla pigrizia, ma mio padre e mia madre sono indomiti: con qualsiasi condizione atmosferica ne fanno uso. E come loro buona parte dei ravennati. E’ comoda, veloce, pratica, è insomma uno strumento che fa vivere meglio, e dà quelle piccole soddisfazioni… specie quando ci sono lunghe file di auto!
E quando la stagione lo permette, e si esce un po’ dalla città, bastano poche pedalate e si respira l’aria del mare o si possono guardare frutteti in fiore. Perdonate, non voglio cadere in un romanticismo mieloso e scontato, ma passeggiare avendo intorno i peschi in fiore ti fa sentire bene, proprio bene. E se poi hai voglia di salire un po’ in collina, il tempo sembra attraversarti in un altro modo, come se si dilatasse. I particolari intorno diventano più nitidi, più brillanti, e spesso ci si accorge di cose intorno a sé di cui si ignorava precedentemente l’esistenza.
Forse azzardo, ma trovo che, ancora oggi, scegliere di inforcare una bici e dare a lei la gestione dei nostri spostamenti, e del nostro tempo, sia un po’ andare controcorrente, abbia cioè un qualcosa di “rivoluzionario”. E questo mi piace.
P.S.: Il testo del citato 44.il coraggio della scelta e di Finisce per A, è presente in un volume che raccoglie alcuni miei copioni che hanno come protagonisti solo personaggi femminili. Si tratta di Anima e carne: donne in scena, ed Fernandel, Ravenna, 2011.
(di Eugenio Sideri)