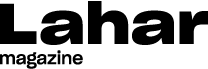Arrivarono in auto alla casa della compagna di classe di Matteo qualche minuto in ritardo, rispetto a quanto Giulia aveva programmato. Del resto non c’era da stupirsi. Era la prima volta che portava il figlioletto a trovare Anna, una delle sue compagne favorite alla prima elementare, e anche se aveva usato il navigatore satellitare si era persa lo stesso un paio di volte, nel dedalo di stradine tutte uguali del quartiere residenziale in cui viveva. In più, la pioggia tardiva di quel maggio li assillava con il suo monotono scrosciare ormai da settimane, e lei detestava guidare con il brutto tempo. Aveva sempre la sensazione che la macchina le scappasse via da sotto il sedere.
Alla fine, comunque, erano riusciti ad arrivare alla loro meta. Era un giorno importante, e una festa importante, perché Anna compiva sei anni. E come le aveva annunciato tutto serio Matteo un paio di giorni prima, parlando dell’evento, voleva dire che ormai stava diventando grande. Lui di anni ne aveva solo cinque, e in certi momenti sembrava pensare che quei pochi mesi di differenza lo rendessero un lattante, a confronto dell’amica.
«Mamma, ci siamo?» chiese una vocina pigolante, emergente da un viluppo di vestiti e copertine che nascondeva quasi del tutto il seggiolino di sicurezza degli Avengers.
Giulia sorrise, mentre ingranava la retromarcia per sistemare meglio la piccola Micra nel posteggio parallelo al marciapiede. Le riuscì sorprendentemente bene, e dentro di sé si congratulò con sé stessa. Spense il motore e slacciò la cintura di sicurezza, valutando la distanza dal bianco cancelletto d’ingresso in ferro, offuscato dalla pioggia battente.
«Si, amore. Siamo proprio proprio arrivati. Hai fretta di vedere Anna?»
«A dire il vero non ne ho mica tanta voglia.»
«Fai sempre così tu. Non ne hai mai tanta voglia, poi fai i capricci perché dobbiamo andare a casa.»
«Non è vero!» borbottò fiero Matteo, offeso nell’orgoglio. «Quello lo fanno i poppanti, e io ormai sono grande!»
«Hai ragione, sei grande. Ma questo non impedisce che tu faccia i capricci lo stesso.»
Lui emerse con la testa dalla confusione che lo ricopriva, e le lanciò uno sguardo che nel suo intento doveva essere minaccioso, ma che ebbe solo il potere di farla ridere di gusto.
«Io non faccio i capricci. È roba da piccoli.»
«Ecco, ricordatelo la prossima volta che ti rotoli per terra perché devi prendere qualche medicina.»
Matteo la soppesò con sguardo critico per qualche secondo, valutando se ingaggiare battaglia o meno. Giunse alla conclusione che non ne valeva la pena, quindi fece un sospiro esasperato per far capire quanto si sentisse accusato ingiustamente, e cambiò argomento.
«Perchè papà non è potuto venire?»
«Lo sai che il papà oggi lavora. Non tutti i papà possono stare a casa quando vogliono, e il nostro è uno di quelli.»
Mentre parlava, valutava quasi senza accorgersene il complesso di abitazioni che si trovava davanti. La casa di Anna era una graziosa villetta a schiera in mattone anticato faccia vista, con una scalinata in pietra grigia che dal marciapiede ben tenuto portava all’ingresso. Aveva anche un bel giardino anteriore, nel quale spadroneggiavano tre nani di gesso e un enorme fenicottero di plastica.
Tralasciando il dubbio gusto delle decorazioni esterne, Giulia si sorprese a provare una punta d’invidia per il sobrio lusso dell’abitazione. Lei, Leonardo e Matteo vivevano in un minuscolo appartamento, in un quartiere popolare. E a dispetto del suo continuo affannarsi per mantenere dignitosa la loro abitazione, sembrava sempre che qualche nuova macchia di muffa facesse capolino sull’intonaco, che gli scarichi puzzassero come se ci fosse morto dentro qualcosa, che i mobili si disfacessero impietosamente tra le sue mani, sconfitti dall’umidità perenne proveniente dagli scantinati del condominio.
La casetta che si trovava davanti era l’apoteosi della borghesia, il trionfo del vorrei ma non posso, una smaccata attestazione di appartenenza alla classe media, se ancora qualcosa del genere era sopravvissuto agli assalti della crisi economica. La mediocrità da ostentare a qualsiasi costo.
Tutto vero, certo. Ma lei avrebbe dato qualsiasi cosa per potersi permettere una casa così. E per consentire a suo figlio di crescere in un ambiente decoroso. Perchè al momento era ancora troppo piccolo, per capire quanto quell’ordinato vialetto in pietra e quella porta d’ingresso in stile inglese lo ponessero su un piano più basso rispetto ad Anna. Ma non ci sarebbero voluti tanti anni, prima che le evidenti differenze tra lui e i suoi compagni di classe gli si evidenziassero con prepotenza, a tracciare un solco invisibile ma invalicabile.
Del resto, con solo lo stipendio da metalmeccanico di Leonardo non è che potessero fare i salti mortali. Inutile pensarci. Tornò a voltarsi verso Matteo.
«Lo sai quanto ti amo, io, si?»
«Si, mamma, lo so. Però non dirmelo davanti ai miei compagni, va bene?»
Giulia rise di nuovo.
«Va bene, va bene, ho capito. Promesso.»
«Posso portarmi la palla di Ben Ten per farla vedere agli altri?»
«Certo, però devi tenerla in mano tu. Io sono piena di cose.»
Scesero dall’auto in un tripudio di borsetta, sportina con i regali, ombrelli e ombrellini, e si diressero al cancello, cercando di evitare i ruscelletti d’acqua che correvano sul marciapiede. O almeno, Giulia cercava di evitarli, Matteo fingeva di farlo, per poi saltarvi dentro a piedi pari. Le si affacciò alla mente per un attimo una fantasia di polmoniti e malattie varie, ma si diede della stupida: tenere lontani i bambini dalle pozzanghere e dall’acqua corrente era come cercare di svuotare il mare con le mani. Tanto valeva che si divertisse.
Suonarono al campanello, e quando il cancelletto esterno si aprì trotterellarono fino alla porta, affrettando il passo. Nonostante gli ombrelli, la pioggia scendeva con tanta violenza da schizzare loro le scarpe e bagnargli i risvolti dei pantaloni. Arrivarono alla pensilina coperta sopra l’ingresso, e Giulia tirò un sospiro di sollievo. Non odiava solo guidare sotto la pioggia, odiava la pioggia in tutto e per tutto. La faceva sentire appiccicosa e bagnaticcia, la immalinconiva, la ricolmava di una tristezza della quale faceva fatica a comprendere l’origine. Forse era solo metereopatica.
Dall’interno della casa veniva il ritmo sordo e incalzante di una canzoncina per bambini, e si udivano occasionali strilli di gioia. La mamma di Anna, della quale non ricordava il nome, aprì la porta per farli entrare, e il rumore dei bambini festanti e della musica crebbe subito d’intensità, colpendole le orecchie. Era una donna gradevole, suppergiù sua coetanea, con i capelli castani tagliati a caschetto e grandi occhi verdi. La gravidanza aveva lasciato sul suo corpo meno segni di quanto aveva fatto su Giulia, o per una genetica più clemente, o per mesi e mesi di palestra e allenatore personale. Sembrava fatta su misura per vivere in una casa come quella: bella senza essere una modella, ricercata senza essere snob, trasudava la sicurezza e la tranquillità che il suo stato sociale le consentivano. Giulia si scoprì a detestarla d’istinto, ma fu comunque brava a stamparsi sul volto un sorriso rigido, e frullare una mano in aria in segno di saluto.
La padrona di casa sorrise a sua volta. Concesse a Giulia un rapido sguardo di incoraggiamento, Dio solo sa quanto sincero, quindi si rivolse al bimbo al suo fianco.
«Ben arrivati! Ciao, Matteo!»
«Buongiorno» rispose lui, educato, sfilandosi la giacchetta impermeabile gialla e guardandosi intorno, alla ricerca dei suoi amichetti. Gli adulti erano già stati estromessi dal suo cono d’attenzione. «Anna c’è?»
«Certo, è di sopra. Tutti i bimbi sono a giocare in camera sua. Sali le scale, e segui la musica. Non dovrebbe essere difficile!»
«Posso stare scalzo?»
«Si, noi qui i bimbi li vogliamo scalzi, altrimenti non li facciamo neanche entrare!» Si voltò verso Giulia, e le diede una rapida strizzata d’occhio. «Il riscaldamento è a pavimento, quindi non prenderà freddo.»
«Uauuuuu! Grazie!»
Matteo piazzò la giacca tra le braccia già stracolme della madre, si sfilò le scarpe, e corse su per le scale come un baleno. Giulia rimase qualche secondo a fissare la scalinata dov’era scomparso il suo unico figlio, quindi rivolse un’occhiata nervosa alla mamma di Anna, che la stava fissando, sorridente come prima.
«Sono sicuri, di sopra?»
«Oh, non si preoccupi. Ci sono un paio di genitori che li sorvegliano, e la camera di Anna è a prova di bimbo. Salteranno e giocheranno, tutto qui. Dia pure a me.»
Le tolse dalle braccia gli ombrelli, la giacca e la borsina con i doni, e li ripose con noncuranza in un armadio guardaroba a sinistra dell’ingresso. I regali, che Giulia aveva selezionato con tanta cura cercando disperatamente di mediare tra un’apparenza decente e un prezzo il più possibile contenuto, finirono in un mucchio di pacchetti di ogni forma e colore.
«Noi adulti ce ne stiamo soprattutto qui sotto, i bambini li lasciamo per conto loro, per quanto possibile» stava intanto dicendo la donna. «Lei vada pure in giro, si serva al buffet, faccia due chiacchiere con gli altri genitori. Si senta come se fosse a casa sua, va bene?»
«Va bene, grazie» rispose Giulia, incerta.
Per la verità, non si sentiva come a casa sua. Le pareva di soffocare. Di essere nel posto sbagliato. Non era la prima volta che aveva delle intuizioni, delle sensazioni, che le provenivano da determinati luoghi. E non avrebbe saputo dire il motivo, ma quella casa, che da fuori aveva tanto ammirato, una volta all’interno sembrava stringerla in una morsa di ghiaccio.
Lo stomaco le si annodò in un canovaccio rigido, e la nuca le si imperlò di fini goccioline di sudore, come spesso le succedeva quand’era in tensione. Ringraziò il cielo per i capelli lunghi, che celavano alla vista quella sua manifestazione emotiva.
Seguì la madre di Anna verso la sala, sentendosi lenta, stupida e del tutto fuori posto. Il locale era vasto, e parecchio luminoso a dispetto del grigio lucore esterno, perché tutte le lampadine erano accese. Il pavimento era in legno d’acacia, e il suo colore chiaro contribuiva alla sensazione di luminosità dell’ambiente. All’angolo sinistro c’era l’immancabile camino di lucido vetro nero, e alle pareti facevano bella mostra di sé una serie di moderne stampe stilizzate. Il tavolo da pranzo era così grande che avrebbe potuto ospitare con comodo una dozzina di persone. Era stracolmo di tartine, salatini, ciotole di popcorn, vassoi di torte, appoggiati apparentemente alla rinfusa. Bottiglie di bibite di ogni tipo erano sparse un po’ ovunque, la maggior parte aperte e bevute a mezzo, a testimoniare che gli ospiti non avevano lesinato gli sforzi per approfittare dell’ospitalità. Palloncini colorati appesi dappertutto davano alla stanza un’aria festosa, e una parete era praticamente coperta dalla scritta “TANTI AUGURI, ANNA!”, in lettere alte cinquanta centimetri.
Le sedie erano state spostate lungo le pareti, in modo da lasciare lo spazio sufficiente per muoversi con comodo, e al momento erano tutte occupate. C’erano almeno una quindicina di adulti presenti, e quelli che non erano riusciti ad accaparrarsi un posto a sedere se ne stavano in piedi, alcuni impegnati in fitte conversazioni, ma perlopiù appoggiati alle pareti a braccia conserte, dando l’impressione di non saper bene cosa fare delle proprie mani.
Giulia abbracciò con un solo sguardo il coacervo di genitori e parenti al seguito dei bambini invitati. A dispetto dell’angoscia montante che percepiva nelle viscere, dovette reprimere un sorrisetto. Era sempre stata convinta che in quelle occasioni emergessero con forza gli stereotipi più divertenti, e ora aveva davanti a sé la conferma di quanto fosse giusto.
Per esempio, ecco il nonnetto pelato che aveva accompagnato il nipotino, perché il papà e la mamma non erano riusciti a prendersi un giorno di ferie. Si era piazzato discretamente in un angolo, cercando di non farsi notare troppo, ben armato di piattino stracolmo di pizzette e gnocco con il prosciutto. Ogni tanto lanciava all’intorno degli sguardi circospetti, e se qualcuno gli avesse rivolto la parola avrebbe avuto già pronto sulla punta della lingua l’argomento principe di tutte le conversazioni imbarazzate della storia, il Tempo Atmosferico, seguito dall’altro grande cavallo di battaglia, il Clima Che Non È Più Lo Stesso. Gli tremava un po’ la mano sinistra, e Giulia si chiese se non avesse un principio di Parkinson.
A occupare due sedie vicine, strategicamente collocate di fianco al ricco buffet, c’era invece la coppia fatta di gelida disapprovazione. Le facce erano atteggiate a un sorriso educato, ma con stampato un sottotitolo ben visibile: chi ce l’ha fatto fare?. La spocchia dei due, però, con tutta evidenza non impediva loro di fare man bassa di dolciumi e tramezzini, almeno a giudicare dal cimitero di piatti di plastica e tovaglioli gettati alla rinfusa sul tavolo. Avevano tutti e due le braccia rigidamente annodate sul petto, e le snodavano solo per afferrare e portarsi alla bocca qualcosa di commestibile.
E ancora, poco più in là, il compagnone, quello che si sentiva fratello di chiunque avesse conosciuto da più di dieci secondi d’orologio. Era il tipo che si muoveva come una scheggia impazzita migrando da un invitato all’altro, quasi sempre imponendo la sua presenza, sentendosi il padrone di casa anche se non lo era. Al momento aveva inchiodato un papà magrolino e occhialuto nell’angolo tra la portafinestra e una bassa credenza di legno, e parlava a ciclo continuo, picchiandogli occasionalmente l’indice contro la spalla, a sottolineare qualche interessante passaggio del suo monologo.
Tutto questo vide Giulia, mentre entrava nel salone stringendo nervosamente la tracolla della sua borsetta da mercato. E a un tratto, l’immagine che le si presentava agli occhi le rimase stampata nella mente come una fotografia, quasi che la realtà si fosse immobilizzata. Un profondo silenzio accompagnava quell’immobile rappresentazione intangibile di ciò che aveva davanti, come se le orecchie le si fossero tappate, impedendo ai suoni di arrivare alla sua coscienza.
Trattenne il fiato, sospesa. Anche questa non era un’esperienza nuova, per lei. Di solito bastava pazientare qualche momento, e tutto si risolveva. Attese, percependo le goccioline di sudore che dalla nuca le colavano tra le scapole.
Poi la mamma di Anna si infilò lesta in una porta laterale, che con tutta probabilità conduceva alla cucina, e il mondo riprese a muoversi. Il chiacchiericcio mormorato tipico delle congregazioni non troppo numerose riprese a far sentire la sua voce. Il nonnetto allungò una mano traballante e fece scempio di un delicato canapè al tonno. Il compagnone riprese a picchiettare la spalla del quattrocchi nell’angolo. La moglie della coppia acida liberò una mano per afferrare un bicchiere di plastica e scolarne il contenuto, mentre il marito chinava un po’ la testa verso di lei, sussurrandole qualcosa all’orecchio.
Nessuno la guardò.
Giulia si era preparata psicologicamente all’attenta analisi che un gruppo di persone già formato riserva al nuovo arrivato. Si era aspettata gli sguardi indagatori degli altri genitori, che ancora non conosceva molto bene. Avrebbero valutato i suoi vestiti un po’ usurati, il suo taglio di capelli fatto in casa, le scarpe da pochi spiccioli, e dentro di loro avrebbero formulato un giudizio, anche se non sapevano nulla di lei. Era pronta per quello.
Ma non era pronta per l’indifferenza. Quella totale mancanza di interesse, quasi che non fosse lì. Era passata dal rango di reietta a quello di invisibile, per motivi a lei ignoti. E alla sensazione di ostilità della casa, che ancora le stringeva la pancia in un viluppo doloroso, si aggiunse quella dell’immeritato ostracismo da parte di tutti quelli che la circondavano.
Lasciò vagare lo sguardo da una persona all’altra, cercando un volto conosciuto, ma non ne trovò. Nessuno ricambiò la sua occhiata, aumentando ancora di più la spersonalizzazione che provava.
Alzò la testa, cercando di recuperare un po’ di dignità. Se non volevano considerarla, lei avrebbe fatto lo stesso. Si avvicinò al tavolo con l’intenzione di prepararsi qualcosa da mangiare in un piattino, e trovarsi un angolo tranquillo dove aspettare che Matteo si stufasse dei giochi con i compagni. Di solito non era una cosa rapida, ma magari quel giorno sarebbe stata fortunata. Dubitava di riuscire a mangiare qualcosa, visto il nodo allo stomaco, però avrebbe dato almeno l’impressione di essere a suo agio. Incespicò sul bordo del tappeto, ma nessuno si volse verso di lei. Guadagnò infine il buffet, rossa in volto, e mentre allungava una mano per prendere un piatto di plastica lo vide.
Il bambino.
Era in piedi davanti al camino spento, di spalle, per cui la sua faccia le era invisibile. Era alto come Matteo, centimentro più, centimetro meno, quindi giudicò che dovesse avere suppergiù la sua stessa età. Indossava un impermeabile rosso vivo, con il cappuccio a coprirgli la testa. Era fradicio di pioggia, che scivolava sulla plastica in rivoletti nervosi, gocciolando poi sul pavimento in legno. Aveva già formato una grossa pozza, e Giulia si chiese in modo irrazionale se l’acqua non avrebbe rovinato il parquet. Dal margine inferiore dell’impermeabile spuntavano un paio di jeans, con chiazze scure di bagnato a disegnare complicati decori irregolari sulla tela. Non aveva scarpe, ma solo le calze, rosse a sua volta, e teneva i piedini incrociati l’uno con l’altro, come se volesse difendersi dal freddo.
E gli adulti intorno a lui sembravano non accorgersi della sua presenza.
Il respiro le si mozzò in gola, e le goccioline di sudore che le colavano lungo la schiena sembrarono congelarsi di colpo, facendole correre lungo il corpo un brivido irrefrenabile.
Il bimbo rimase immobile. Sembrava che una vibrazione gli percorresse il corpo a intervalli regolari, come se fosse agitato da un vento furibondo, ma nient’altro.
Guardò quell’apparizione, ripensando alle occasioni in cui le era capitato di vedere e sentire cose strane. Quand’era piccola, sua nonna le raccontava che le donne della sua famiglia avevano un modo particolare di guardare il mondo. Che avevano la facoltà, e che questa facoltà saltava una generazione, per ripresentarsi in quella successiva. Che non importava quanto la allenassi, o la mettessi alla prova, o la ignorassi. Ce l’avevi, e tanto bastava.
Dopo che la nonna era morta, ai tempi in cui lei faceva la quinta elementare, l’aveva vista tante volte. Non ne era rimasta spaventata, perché sua nonna l’aveva amata, e non le avrebbe mai fatto del male, anche se era morta. E lei l’aveva incontrata, e le aveva parlato.
Poi la nonna era scomparsa per non fare più ritorno, e la facoltà non le aveva più mostrato nulla di così definito. Solo vaghe sensazioni spiacevoli, o groppi alla gola in luoghi con un’energia particolare, diciamo così.
Fino a quel giorno.
Osservò a lungo il bambino, respirando con calma, cercando di non perdere il controllo. Ripensò a sua nonna, che le raccontava di come la facoltà ti faceva vedere le cose in modo più o meno esplicito, a seconda della loro forza. Della potenza del loro amore. O del loro rancore.
E quel bambino non sembrava ricolmo d’amore. Per nulla.
Si impose di calmarsi. Non era detto che fosse davvero la manifestazione di una cosa morta. Magari era il figlio di uno dei presenti, che voleva rimanere vicino al papà o alla mamma, prima di andare a giocare con i compagni.
Si, e secondo te un qualsiasi genitore lascerebbe il figlio in casa con addosso l’impermeabile zuppo, e i piedi scalzi in una pozza d’acqua? Genio che sei. Diciamo che non vuoi ammettere la verità.
Forse. Forse era così.
Con un sussulto si riscosse, e si rese conto che il suo rimanere ferma a bocca spalancata, con il braccio allungato e immobile a mezz’aria per prendere un piattino, era infine riuscito ad attirare l’attenzione su di lei. Adesso sembrava che la stessero fissando tutti.
Si schiarì la voce. Evitando di guardare di nuovo il bambino, sfilò a fatica un piatto di plastica dalla sua pila, e si accinse a metterci dentro qualcosa. Sollevò con una mano incerta una fettina di pizza, che sembrava un pezzo d’animale squartato, e la ficcò nel piatto. Poi due o tre piccole meringhe, ricoperte di allegri zuccherini multicolore, e una fetta di torta al limone. In realtà non stava neppure guardando quello che prendeva, l’importante era fare qualcosa.
Sempre respirando con regolarità, si girò verso la porta nella quale aveva visto sparire la madre di Anna, e la raggiunse a passi lenti e misurati. Uno sguardo all’interno le bastò per rendersi conto che il suo intuito aveva visto giusto, la cucina era davvero lì. Era arredata in stile moderno, con mobili bianchi a contrasto con le pareti verniciate di grigio scuro. Era molto ampia, come la sala, del resto, tanto che i proprietari erano riusciti a installare un’isola centrale con cappa sospesa, una cosa che lei aveva visto solo nei film o nelle riviste d’arredamento. Al suo interno si aggiravano alcune persone, curiosando negli stipiti e nel frigo, senza preoccuparsi dell’intrinseco malgarbo dell’azione. La mamma di Anna non c’era, quasi di sicuro era uscita mentre lei era al buffet.
Un uomo sbucò da dietro la porta e la fronteggiò. Dimostrava una settantina d’anni, non era tanto alto, era magro e distinto, con una folta chioma di capelli canuti. Indossava una camicia bianca, tenuta fuori dai jeans, abbastanza lunga da arrivare a coprirgli il bacino. Giulia si sorprese a pensare che quello sconosciuto assomigliava a suo padre. Si fermò per un attimo di fronte a lei, fissandola dritta in faccia. Era strano che lo potesse fare, perché aveva gli occhi bianchi, quindi forse era cieco. Ma nonostante questo, si sentì penetrare da quello sguardo come se fosse una lama.
L’uomo si mosse e le scivolò di fianco, uscendo dalla stanza. Aveva una cicatrice a forma di mezzaluna sulla guancia sinistra.
“Non dovresti essere qui” le mormorò, mentre passava.
Giulia rimase interdetta, senza sapere cosa rispondere. Pronunciare una frase del genere nei confronti di qualcuno che non si conosceva le sembrava una grossa scortesia. Chiaro che al mondo c’erano persone di ogni tipo.
Era ancora ferma sulla soglia del locale, ragionando su quello che quell’uomo le aveva detto, quando si sentì spinta a voltarsi. Non era un atto volontario, il suo, non era una cosa che desiderava. Al contrario. Ma non poteva proprio farne a meno.
Tornò a girarsi verso la sala, verso il camino, con negli occhi lo sguardo disperato della bestia che si avvicina al macello. Il bambino non c’era più.
Si aggirò per la cucina, indecisa sul da farsi, con il piattino tenuto davanti al petto a mò di difesa, come uno scudo. Arrivò all’ampia finestra, e diede un’occhiata fuori. La pioggia scendeva ancora copiosamente, e anche se sembrava impossibile il cielo era diventato più tenebroso di quando erano arrivati. Gli adulti che gironzolavano nella stanza quando lei era entrata erano tornati in sala, e ora il locale era tutto suo. L’idea strisciante che si fossero allontanati perché non avevano voglia di rimanere in sua compagnia le balenò per un attimo alla mente, ma la scacciò subito. Non aveva la minima intenzione di cadere in paranoia.
A seguire, desiderò essere con suo figlio, e fuori da quella casa: la vista del bimbo fantasma l’aveva proprio scombussolata. Ma non potevano andare via subito, Matteo ci sarebbe rimasto troppo male. Già aveva poche possibilità di giocare con i suoi coetanei, scuola a parte. Se gli avesse tolto anche quelle occasioni sarebbe stata una madre riprovevole.
Appoggiò il piattino sull’isola, senza averne toccato il contenuto. La fame in quel momento era ai minimi storici. Il suo sguardo fu catturato da una grande stampa, appesa alla parete sopra il tavolino per la colazione. Era l’immagine in primo piano di una vettura sportiva, nera, aggressiva. Le ruote e lo sfondo erano sfumati da nette linee orizzontali, a dare l’idea della velocità. I fanali, delineati da sottili strisce di led, sembravano gli occhi lampeggianti di un drago, e la bassa mascherina anteriore assomigliava a una bocca spalancata in un ringhio. Dava l’impressione di essere lanciata senza pietà verso qualche vittima ignara. Non ne sapeva abbastanza di auto per riconoscerla, ma le parve simile a una di quelle americane piene di cavalli, una Mustang, forse, o una Camaro.
Era solo la fotografia di una macchina, ma le riaccese di nuovo nella pancia quelle fitte profonde che aveva percepito in precedenza.
Fece qualche passo, considerando l’idea di salire al piano superiore e vedere come stesse Matteo, quando la macchina si mise in movimento. Giulia rimase a bocca aperta, immobilizzata da quell’assurda novità. Per una frazione di secondo, cercò di convincere se stessa che quella che aveva scambiato per una fotografia era in realtà un qualche genere di schermo ultradefinito che non aveva mai visto, ma era inutile raccontarsi palle, giusto? Quello era un quadro. E si era appena animato davanti ai suoi occhi.
La vettura correva lungo un nastro di strada asfaltata, disegnando morbide traiettorie nelle curve appena accennate di quell’assurdo e monotono panorama. I vetri scuri impedivano di vedere chi fosse al volante, ma lei sentì senz’ombra di dubbio che si trattava di una persona cattiva. Molto cattiva. Lo si intuiva dal modo in cui sterzava, dalla veemenza con la quale la macchina scattava in avanti sui brevi rettilinei, e persino dal rombo irrequieto del suo potente motore. Si, perché sentiva anche il suono, provenire da un punto indefinito nello spazio di fronte a lei. Era aggressivo, rombante, rotondo. E tuttavia, le dava una sensazione strana. Perché non assomigliava del tutto a un motore, no? No, pareva più simile al rumore che potrebbe fare un bambino che imiti il motore di un’auto sportiva.
Giulia si avvicinò alla stampa, raggelata, malgrado si sentisse le gambe molli. Allungò una mano, senza neanche accorgersene, e sfiorò con le dita la superficie rugosa dell’illustrazione. La pelle le restituì una percezione vibrante, come se si fosse appoggiata a una lavatrice in centrifuga. Mosse piano la mano avanti e indietro, ammaliata e disgustata allo stesso tempo, finché il quadro si staccò dalla parete, e cadde al suolo con un tonfo secco. Lei si lasciò sfuggire dalle labbra un gridolino sorpreso, poi una mano si posò sulla sua spalla, e allora gridò davvero, senza mezzi termini. Si voltò col fiato corto, e si trovò davanti il volto sorridente della madre di Anna. La donna la guardò in faccia, poi il suo sguardo scivolò sulla stampa, che era caduta sul pavimento a faccia in giù.
«Mi scusi, non volevo…cioè…» balbettò Giulia, sconvolta.
La donna sollevò una mano, e la mosse in un gesto indulgente.
«Non si preoccupi, tanto questo quadro si stacca sempre.»
Si chinò sotto il tavolino a recuperarlo, quindi lo tenne stretto tra le mani, contemplandolo per un momento.
«Ho detto mille volte a mio marito di fissarlo meglio, ma sa come sono gli uomini. Se non fosse che mi piace davvero tanto, me ne sarei già liberata.»
Riappese con un gesto lezioso la stampa alla parete, e se ne allontanò di un paio di passi, con un’espressione soddisfatta.
«Ecco fatto. Vediamo quanto dovrà passare prima che cada di nuovo.»
Giulia non la stava ascoltando. Stava fissando l’immagine appesa. Una fila di grandi cucchiai bianchi su uno sfondo di legno grezzo, pieni di spezie e frutti dei più svariati colori.
La macchina non c’era più.
Attraversò a passo svelto la sala piena di persone, incurante degli sguardi incuriositi che le venivano lanciati dagli altri genitori. La sola cosa che contava per lei era trovare Matteo e andarsene, andarsene da lì, il prima possibile. Arrivò alla scala che conduceva al piano superiore, e fece le due rampe quasi di corsa, afferrandosi al corrimano di legno. Raggiunse il ballatoio, ansimando, e lì si immobilizzò per un istante, confusa. Ecco che accadeva di nuovo. Ancora la realtà scompariva, sotto una patina di immagini fittizie.
Il corridoio sembrava allungarsi all’infinito di fronte a lei. La parete alla sua sinistra e quella alla sua destra erano intervallate da porte tutte uguali, disposte alla medesima distanza l’una dall’altra, tutte ermeticamente chiuse. Udiva con chiarezza il rumore festante della musica e le grida gioiose dei giochi dei bimbi. Le davano l’impressione di essere dannatamente vicini, ma non aveva idea di dove fosse la stanza in cui si trovavano.
Accennò qualche passo avanti, incerta, appoggiandosi al muro solido, e raggiunse la prima porta. Tentò la maniglia, ma quella si mosse su e giù, e la porta rimase chiusa. Provò quella dall’altro lato, ma era chiusa anche quella. Avanzò, tentando una porta dopo l’altra, sempre più affannata, gemendo e sussurrando il nome di Matteo. Andò avanti, e avanti, finché girandosi da dove proveniva non riuscì a vedere altro se non un corridoio infinito come quello verso il quale si stava dirigendo. Ma non aveva paura di quello, no, l’angoscia che la ricolmava era di non riuscire più a trovare suo figlio. Di averlo perduto per sempre.
Giunse davanti a una porta uguale a tutte le altre, abbassò la maniglia, e questa volta riuscì ad aprirla. Dietro c’era solo una specie di minuscolo sgabuzzino, buio, del nero profondo degli abissi oceanici. Non semplice mancanza di luce, ma oscurità nella quale la luce non era mai arrivata.
Dalle tenebre emerse il vecchietto canuto che aveva incontrato in cucina. Si sporse di scatto verso di lei, il volto deformato in una smorfia, gli occhi ciechi e tuttavia sapienti, e l’afferrò per le spalle.
«Questo non è il posto giusto per tè, non dovresti essere qui» gracchiò, nel suono distorto di un disco a 45 giri riprodotto a 33.
Giulia gettò un urlo, sfuggendo alla sua presa, e richiuse la porta con tanta violenza da aprirvi una crepa. La maniglia si contorse su e giù tra le sue mani, mentre chi stava dall’altra parte spingeva con tutte le sue forze per aprire, sputacchiando e sibilando in una serie di suoni a lei sconosciuti. Urlò di nuovo, stavolta di autentico orrore, per suo figlio e per sé, mentre combatteva strenuamente contro il vecchio cieco che voleva ghermirla.
«Mamma?»
Si riscosse, con un fremito, e vide che il corridoio era tornato normale. La porta che aveva davanti, di cui stringeva ancora la maniglia tra le mani, era una comunissima porta. Si girò alla propria sinistra, e Matteo era lì, che la guardava con un’espressione confusa, come se fosse impazzita. Dietro di lui, dalla stanza successiva, facevano capolino un paio di teste di bambini. Ridacchiavano. C’era anche un adulto, un papà, che fissava la scena con espressione preoccupata.
«Tutto bene, signora?» le chiese, con sollecitudine.
Era chiaro che aveva dato spettacolo.
Non gliene importava. La sola cosa che contava era avere ritrovato suo figlio. E ora dovevano solo scappare da quella casa, fuggire, darsela a gambe, il prima possibile. Si girò verso di lui, senza riuscire a trattenere le lacrime, e allungò le braccia nella sua direzione, ignorando la domanda che le era stata rivolta.
«Matteo. Vieni, abbracciami.»
Il bambino la guardò ancora per un attimo, poi si voltò per controllare cosa stavano facevano i suoi compagni. Constatato che erano tutti rientrati nella cameretta di Anna, e che quindi non potevano vederlo, fece spallucce e le si avvicinò. Giulia gli si inginocchiò davanti, chiuse gli occhi e lo strinse più forte che poteva.
«Tesoro, mi sei mancato. Mi sei mancato tanto» gli mormorò.
«Mamma, ero solo a giocare» rispose lui, con la testa affondata tra i suoi seni.
«Si, lo so, ma ora è tardi. Dobbiamo rientrare, prima che torni papà.»
Fu percorsa da un nuovo brivido. Era stata così in tensione per quello che le stava succedendo che le mani le si erano ricoperte di un velo di traspirazione. Le sentiva scivolare l’una sull’altra, calde e viscose, con un vago rumore liquido.
«Ma io voglio stare a giocare ancora un po’!» protestò Matteo, con voce sorda. «Non hanno neanche portato la torta!»
«Non mi interessa» puntualizzò lei. «E poi hai già giocato abbastanza. Senti, sei tutto accaldato. Non vorrai ammalarti.»
Percepiva infatti sul petto e sulle braccia il calore bruciante del suo sudore, che gli sgorgava a fiotti dalla fronte e le colava sul maglioncino leggero, sulle braccia, sulle cosce. Le sue ginocchia erano affondate in una pozza liquida, le sentiva che si appiccicavano sul pavimento di legno.
Aprì gli occhi. Non era normale che sudasse così tanto.
Di fronte a lei, alla fine del corridoio, c’era un muro cieco, e in quel muro era stato collocato un grande specchio a figura intera. Giulia vedeva il suo riflesso, inginocchiata al suolo, con Matteo stretto tra le braccia. Solo che non era Matteo.
Le ci volle qualche secondo, per afferrare a pieno il significato di quel che le diceva la vista. Non stava stringendo suo figlio. Il bambino che aveva tra le braccia indossava un impermeabile rosso. Si sentì congelare. Gli pareva di avere tra le braccia un blocco di ghiaccio.
«Non mi ammalo, mamma, non ti preoccupare» disse l’essere, con la voce arrochita. «Posso ancora cinque minuti?»
Giulia se lo scostò bruscamente dal petto, stringendolo per le spalle, ansimando per il terrore. Era lui. Era il bambino fantasma. Ma c’era qualcosa che non andava. Fissò il bimbo senza capire cosa fosse, poi ci arrivò: l’aveva visto di spalle nello specchio, quindi ora avrebbe dovuto guardarlo in volto. Invece, come in un dipinto di Magritte, continuava a vederlo di schiena. Gettò uno sguardo allo specchio, e anche lì lo vide da dietro.
«Che succede, mamma?» chiese il bimbo, in un rantolo. «Che succede, mamma? Che succede, mamma? Che succede, mamma?»
Continuò a ripeterlo, e ripeterlo, in un’assurda e incalzante cantilena, e Giulia ebbe la sensazione che la sua sanità mentale potesse spezzarsi da un momento all’altro. Si alzò in piedi e corse verso la seconda porta, quella dalla quale aveva visto uscire i compagni di Matteo. Si udivano musica, risate, sporadici rumori di oggetti di plastica che cadevano al suolo. Irruppe nella stanza, e mentre lo faceva tutto ammutolì di colpo. I rumori si spensero, lasciando nell’aria dietro di loro un eco innaturale.
Nella camera non c’era nessuno.
Giulia arretrò un paio di passi, respirando pesantemente, muovendo la testa a destra e sinistra in segno di diniego. Non era vero. Tutto quel che vedeva non era vero. Non era possibile che stesse succedendo.
Ritrovò la voce.
«MATTEO!» gridò, con quanto fiato aveva in gola.
Il suo urlo rimbalzò tra le pareti della casa, che parvero ridere per l’inutilità delle sue rimostranze. Tornò in corridoio, e il bambino con l’impermeabile non c’era più. Chiamò ancora suo figlio, a squarciagola, ma non ci fu risposta. Spalancò una dopo l’altra le altre due porte che si affacciavano sul corridoio, rivelando la camera padronale e il bagno principale. Nessuno neanche lì. Forse al piano di sotto?
Volò per gli scalini, saltandoli a due a due, fino a tornare alla sala. Anche quella era deserta. Il cibo sulla tavola era marcito, putrescente, e si stava sciogliendo in una fetida decomposizione, colando in umori disgustosi sul pavimento. Le luci avevano assunto una tonalità rossastra, malata e spenta, gli ultimi palpiti di un fuoco morente. Da sotto il tavolo della sala strisciò fuori il vecchio, trascinandosi con le mani nella sua direzione. Giulia arretrò, orripilata: non aveva più le gambe. I moncherini finivano in un guazzabuglio di ossa, tendini, nervi, muscoli squarciati, e lasciavano due nere strisce di sangue semicoagulato sul legno chiaro. Il vecchio sollevò gli occhi ciechi nella sua direzione.
«Non dovresti essere quiiiiiii…»
La sua voce si sciolse in un fischio acuto, poi diminuì d’intensità, quindi svanì di nuovo nel silenzio. La testa del vecchio cadde al suolo con un tonfo pesante, mentre le sue dita grattavano insensatamente il legno, con un lieve rumore di tarlo.
Giulia lo tenne d’occhio un attimo, per timore che potesse balzare in aria come un orribile pupazzo a molla da una scatola, poi si precipitò in cucina. Vuota anche quella.
«MATTEO!» urlò di nuovo.
Ancora il suo appello si spense nel nulla. Disperata, uscì dalla cucina e si diresse all’ingresso. Stava per arrivare alla porta d’ingresso, quando la madre di Anna sbucò dal ripostiglio dei doni, strappandole un gridolino di sorpresa. Era ancora sorridente, e la osservava a braccia conserte, come si potrebbe osservare un interessante esemplare di insetto raro.
«Dove vorrebbe andare?» si informò, in tono educato.
«Dov’è mio figlio?» rispose lei, la gola in fiamme per le lacrime e il troppo urlare.
«Suo figlio? Oh, ma signora, suo figlio non è più qui» disse la donna, socchiudendo gli occhi in un’espressione meravigliata. «Non c’è più da un pezzo.»
«Cosa? Cosa…cosa vuol dire che non…»
«Lei l’ha già portato via, molto tempo fa» la interruppe l’altra, facendole ala verso l’ingresso.
Giulia si avvicinò, titubante, e giunse alla porta a riquadri di vetro. La pioggia spazzava ancora il mondo. Gettò uno sguardo oltre il vialetto, e vide la sua Micra parcheggiata a pochi metri dal cancelletto del giardino. Lontano, le parve di udire il brontolio continuo di un tuono.
E sul vialetto, saltellante nella sua giacchetta gialla, diretto verso il marciapiede esterno, vide Matteo. Camminava a fianco di una donna non tanto alta, con i fianchi un po’ ingrossati, che reggeva un ombrello grande a sufficienza da coprirli tutti e due. Aveva un ombrellino azzurro da bambino appeso al braccio sinistro. Era vestita con abiti dozzinali, ma si vedeva che aveva fatto uno sforzo per cercare di abbinarli nel modo giusto. Il bimbo si voltò verso di lei, sorridendo, e la donna si girò a sua volta. Gli stava parlando, perché la sua bocca si muoveva.
Era la sua faccia. Era lei.
Giulia appoggiò le mani ai due lati della porta, sugli stipiti di elegante legno bianco, e si guardò, a bocca aperta, mentre parlava con suo figlio. Probabilmente gli stava raccontando una barzelletta. Matteo le adorava, anche se ancora non le capiva del tutto. Il bimbo infatti scoppiò a ridere, e anche se i suoni le arrivavano attutiti, la sua gioia era innegabile.
Il rombo del tuono, nel frattempo, era aumentato d’intensità. Pareva provenire dai muri stessi della casa, e le faceva vibrare dolorosamente i timpani. I due all’esterno non parevano udirlo, perché continuavano a chiacchierare come se niente fosse. La donna arrivò al cancello esterno e lo aprì con una mano, mentre con l’altra teneva stretto l’ombrello. Matteo sgusciò nel pertugio che si era aperto e scese sul marciapiede. Il tuono rimbombava ancora più forte, e i vetri della porta tremavano all’unisono con le pareti.
Non era un tuono.
Giulia appoggiò atterrita il volto al vetro e guardò verso destra, verso la sommità della strada in leggera salita che passava davanti a casa di Anna.
Da dietro un gruppo di alberi sbucò una vettura nera, del tutto simile a quella che aveva visto muoversi nel quadro in cucina.
«No, no, no…» sussurrò, scuotendo l’intelaiatura della porta con le mani.
L’altra Giulia stava armeggiando per richiudere il cancelletto. Matteo la stava aspettando, ubbidiente, facendo saltellare la sua palla di Ben Ten da una mano all’altra.
Giulia cominciò a picchiare con foga le mani sulla porta, cercando di attirare la loro attenzione, sperando di poter evitare quello che stava per accadere. Si accanì sulla porta, ma non aveva modo di aprirla. Poteva solo assistere, impotente.
L’auto accelerò la sua corsa, e il motore emise un ruggito cavernoso, simile a quello di un leone, mentre si dirigeva verso di loro. La donna sollevò finalmente lo sguardo, e vide l’auto. Anche Matteo alzò gli occhi, incuriosito, e nel farlo la palla gli cadde dalle mani, rimbalzando verso la strada. Fu una questione di frazioni di secondo, ma Giulia avrebbe potuto descriverne ogni piccolo particolare, fin nell’ultima, minuscola immagine. Matteo corse giù dal marciapiede per recuperare la sua palla, e si infilò nello spazio tra due auto parcheggiate. Sbucò sull’asfalto proprio mentre arrivava la vettura nera, lanciata a tutta velocità. La donna, che stava assistendo alla scena, non fece neppure in tempo ad alzare un braccio o cacciare un grido, per tentare di impedire l’ineluttabile. L’avrebbe fatto, e a lungo, ma quando ormai era troppo tardi.
Il bambino venne colpito in pieno dal paraurti della vettura, e sbalzato lungo la strada come una bambola di pezza. Giulia urlò, e la Giulia sul marciapiede urlò a sua volta, in un’unica nota sincrona mantenuta dall’orrore. La macchina nera inchiodò sull’asfalto bagnato, facendo uggiolare i copertoni. Scodò alcune volte a destra e sinistra, prima di urtare con violenza un’altra auto parcheggiata e infine fermarsi, con il cofano fumante.
La donna lanciò al suolo borsetta, ombrelli, borsine, e volò verso il corpo di suo figlio, che giaceva riverso in mezzo alla striscia di asfalto battuto dalla pioggia, gli arti sgraziatamente abbandonati al suolo in angoli innaturali. Anche da quella distanza, Giulia riuscì a vedere l’altra sé stessa che girava il corpo del bimbo, stringendolo, accarezzandolo, piangendo e urlando. Era evidente che non c’erano speranze. Il sangue colava copioso dal suo volto, sporcandogli di rosso l’impermeabile, chiazzandolo al punto da fargli cambiare colore. Per la violenza dell’urto aveva perso le scarpe, e i pantaloni e le calze erano madidi di pioggia.
Giulia si staccò dalla porta, piangendo. Non aveva bisogno di vedere altro.
Ora ricordava. Ricordava ogni cosa.
Si voltò verso la madre di Anna, che la guardava con benevolenza.
«È morto.»
L’altra annuì.
«Si. Lo è.»
«Mentre tornavamo a casa dopo la festa?»
«Esatto.»
«E io sono un fantasma?»
«No, non lo sei. Sei dentro la tua mente, ora. La tua coscienza si è spezzata, non riesci più a emergere al mondo reale.»
«Com’è possibile? Mi sembra tutto così vero…»
«Per te è come se lo fosse. Ogni esperienza che viviamo è tale solo perché il nostro cervello ci dice che lo è.»
Giulia rifletté per qualche tempo, nel continuo scrosciare della pioggia all’esterno. L’acqua ruscellava lungo i vetri delle finestre, ottundendo la luce esterna, pennellando di una sfumatura grigia ogni superficie intorno a loro. Alla fine alzò lo sguardo.
«Quindi, stare qui è come vivere davvero.»
La madre di Anna sorrise di nuovo.
«In realtà si, se tu vuoi che sia così.»
«Posso dimenticarmi di essere in una creazione della mia immaginazione?»
«Certo che puoi. L’hai fatto tante volte. E se sarai abbastanza tenace, non ti renderai mai conto della differenza.»
«Allora, come mai mi sono ricordata della sua morte? Dell’incidente?»
«Perchè dall’esterno ci sono persone che tentano di riportarti da loro. Nel mondo reale. E a volte, i loro tentativi ti fanno tornare alla memoria quello che è accaduto.»
«Leonardo?»
«È uno di loro, si. Gli manchi. E se vuoi, puoi decidere di tornare da lui.»
«Mi stai dicendo che devo scegliere se passare la vita qui, con Matteo, o fuori, con persone vere, nella realtà, ma senza di lui.»
«Esatto.»
«È una scelta orrenda da compiere.»
«Lo è. Ma dev’essere fatta.»
Giulia ammutolì, riflettendo. Gettò lo sguardo fuori dalle finestre, anche se ormai non si vedeva assolutamente niente. Pensò a Leonardo. Al fatto che l’amava. A tutti i momenti felici che avevano passato insieme. Le mancava.
La madre di Anna le appoggiò una mano sulla spalla.
«Hai preso la tua decisione?»
Lei sollevò lo sguardo, e i suoi occhi erano brillanti, di lacrime ma anche di gioia. Annuì.
«Si. Si, l’ho presa.»
Era sera. Nella stanza d’ospedale la luce fredda dei neon disegnava ombre nitide, che non contribuivano a mitigare l’aleggiante sensazione di impersonale freddezza. Al capezzale di Giulia, che giaceva sdraiata nel letto a occhi chiusi, c’erano due persone. Una era Leonardo, il marito. L’altra era il medico che la seguiva ormai da una decina di giorni, da quando l’avevano trasferita lì in stato catatonico.
Leonardo si stava torcendo le mani, disperato. Aveva perso un figlio da poco, per una tragica fatalità, e ora gli sembrava di essere prossimo a perdere anche la sua amata moglie. Era un uomo pratico, e l’idea di non poter fare nulla per Giulia gli toglieva il sonno.
«Ma non c’è qualche cosa da tentare per risvegliarla?» chiese, forse per la centesima volta. «Qualche terapia d’urto? Qualche psichiatra? Una cazzo di musica da farle ascoltare?»
Il dottore scosse la testa, mortificato. Avrebbe voluto potergli dare delle notizie migliori. Era un uomo sulla settantina, con i capelli bianchi, e il camice perfettamente stirato. Se avesse potuto vederlo, Giulia l’avrebbe di certo riconosciuto. E in caso di dubbi, la cicatrice a mezzaluna sulla sua guancia sinistra glieli avrebbe tolti subito.
«Non penso sia in nostro potere modificare più di tanto quello che sta succedendo dentro di lei. Possiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo, e aspettare.»
«Aspettare? Aspettare cosa?»
«Che trovi da sola la strada per superare il suo trauma. E pregare che, se ha degli incubi, non siano troppo crudeli con lei.»
Leonardo si zittì, e si rimise a sedere sulla sedia di fianco al letto di Giulia. Le prese la mano, e le sussurrò quanto l’amava. Lei rimase immobile come una statua, con un vago sorriso che le aleggiava sulle labbra.
Si ridestò di colpo, come se le fosse risuonata una sveglia nella mente. Era seduta su una panchina, nel bel mezzo del grande parco pubblico che iniziava poche decine di metri dietro il loro condominio. Era una giornata calda e soleggiata, senza nuvole a interrompere la pastosa continuità del cielo ceruleo. Si era portata dietro un libro, per il riposino dopo la passeggiata pomeridiana, ma il tepore primaverile l’aveva sconfitta, e si era assopita.
Matteo. Dov’era Matteo?
«Matteo!» urlò, alzandosi in piedi di scatto.
«Sono qui, mamma» disse una vocina dietro le sue spalle.
Si girò, sentendo il cuore martellarle nel petto come un tamburo. La testolina ben ordinata di suo figlio fece capolino dal margine dello schienale di legno. Gli occhi erano calmi e luminosi. Le spedì un sorriso di infinita dolcezza.
«Ti eri addormentata, eh?»
Lei sentì un tale groppo di amore nel petto da farle pensare che le si sarebbe fermato il respiro.
«Un pochino. Ma tu sei stato bravo, non ti sei allontanato.»
Il bimbo la guardò, come se fosse uscita di senno.
«Non lo farei mai. Mamma, non trattarmi sempre come un neonato!»
Giulia sorrise a sua volta.
«Va bene, te lo prometto. Ora che ne dici di andare a casa, e fare un po’ di pancake?»
«Con lo sciroppo?»
«Con tutto quel che vuoi.»
«Evviva!»
Matteo girò attorno alla panchina, abbracciandole per un attimo una gamba, prima di afferrarle la mano.
«E dopo mi fai delle coccole?»
«Dappertutto. Anche sul pancino.»
«Evviva ancora!»
Giulia fece un sospiro soddisfatto, e alzò il volto verso il sole, grata per i tiepidi raggi che le accarezzavano il volto. Odiava la pioggia. Molto meglio, così.
Tenendo Matteo per mano presero la strada verso casa, chiacchierando amabilmente.
In lontananza, nuvole scure iniziarono a fare capolino dall’orizzonte.