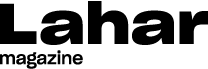Nella Terra Bianca non c’era molto da fare se non sistemare i libri nell’archivio dell’ospedale in ordine cronologico, spartire le provviste dalla mensa e osservare i ciechi che si uccidevano al di là del canneto che confinava con la spiaggia. Lì era dove avevamo lasciato il mondo marcire. Anche i ciechi avevano il mare, ma era un pericolo come un altro con cui mettere a rischio quel che rimaneva della loro vita. C’era anche la mia famiglia, lì. Non potevamo farci niente, diceva Sevil, nella promessa che una volta messa a punto la Macchina avremmo pianificato una missione di recupero. Sevil era alto, con i capelli lunghi e scuri e la sua ombra ondulava nera sui granelli di marmo della nostra costa. Rifletteva un sacco perché era lui a gestire tutta la struttura e quello che vi accadeva. L’ospedale aveva cinque piani ed era largo circa quanto una decina di campi da calcio, ma non potevamo utilizzarli tutti: c’erano delle aree proibite. E anche degli orari proibiti. La notte, ad esempio, non potevamo uscire, precisamente da quando il sole cominciava a calarsi lento lungo la linea che separava il cielo dal mare, e questo si colorava di giallo e arancione e rosso: le braccia del diavolo, diceva Sevil. Sapevamo tutti che si trattava solo dei raggi solari e che non c’era nessun diavolo che discendeva dal basso degli Inferi per bruciarci gli occhi, o perlomeno io non ci credevo, per questo ogni tanto sgattaiolavo fuori attraverso la porta sul retro del nido, che era deserto, e se l’acqua era buona facevo anche il bagno. Una volta Sevil mi aveva beccato con i capelli umidi che ancora odoravano di salsedine e mi aveva trascinata in cappella. Mi aveva guidata sotto l’abside e aveva aperto il grosso libro della Bibbia, ne aveva sfogliato una ventina di pagine con cura meticolosa, la stessa con cui sceglieva le parole per spiegarci quello che non sapevamo, e infine mi aveva obbligata a leggere un passo in cui Gesù o qualcun altro ordinava ai suoi discepoli di vestirsi delle armi della luce quando si avvicina la notte, e di spogliarsi delle opere delle tenebre al sorgere del giorno. Poi mi prese per le spalle e si abbassò per stare alla mia altezza: “Sei giovane, Cam” mi disse, come se fosse preoccupato per me, “Non buttare via la tua anima nella carne. È giusto che tu soddisfi i tuoi desideri, ma ricorda che tu sei sveglia.”
Non capii esattamente, così il giorno dopo ne parlai a pranzo con Rubik. Rubik era la mia compagna di stanza. Aveva certi ricci che mi piaceva spazzolare quando usciva dalla doccia, anche se lei lo detestava: voleva che rimanessero selvaggi, come lei e la sua intelligenza.
“Vuol dire arriverà la fine e tu sarai giudicata, ma più dei ciechi, come tutti noi. Le sue solite cose religiose”. Neanche lei ci credeva tanto, ma quantomeno ascoltava le parabole; le piaceva imparare un po’ tutto, e quando poteva si chiudeva da sola negli archivi. Col tempo impallidiva e Sevil la rimproverava di uscire durante il giorno, a passeggiare con gli altri, ma lei lo ignorava. Seguiva le regole e non poteva essere cacciata, anche se scommettevamo che Sevil l’avrebbe fatto volentieri. Notò che corrucciai le sopracciglia e si disse che forse era stata un po’ sbrigativa. Nel mentre ingurgitava la sua pasta con i fagioli direttamente dal contenitore di latta: “Noi siamo svegli, per questo siamo più colpevoli se sbagliamo. Al momento del giudizio, se ci sarà, qualcuno conterà i nostri errori. Lui ci vuole puri”.
“E io voglio fare il bagno al tramonto, perché l’acqua è piatta e limpidissima”. “Non ti accetteranno mai in paradiso se continui a puzzare di alghe”.
“Ma perché si preoccupa di queste cose?”.
“Te l’ho detto. Le sue cazzate bibliche. Ci sguazza a farci da prete. Forse si crede il nuovo Gesù e vuole redimerci. Ci vuole puri. Per me è un po’ uscito di testa”.
“Solo perché ti odia”.
“Solo perché sono sveglia”.
“Anch’io sono sveglia”.
Posò la latta sul tavolo e ci mise dento il cucchiaio. Poi terminò il discorso dicendomi che intendeva un’altra cosa. Lasciai cadere la forchetta nel piatto di plastica ma ormai si era già precipitata fuori dalla stanza con i libri dell’archivio. Normalmente ognuno di noi ci trascorreva dai trenta ai sessanta minuti al giorno. Rubik faceva orario continuato. Non era vietato leggere i libri, ma raramente qualcuno di noi lo faceva. Tranne lei. Cercava una specie di chiave che avrebbe risolto tutto e svegliato i ciechi. Ogni tanto mi trattenevo con lei, anche se il mio aiuto consisteva più che altro nel catalogare i libri a seconda dell’argomento e cercare quelli presenti sulla sua lista. Se ero fortunata erano già stati disposti sugli scaffali, altrimenti dovevo tuffarmi nell’oceano di carta e nuotare fino a quando non trovavo quelli giusti. La lista era il retro dell’indice di un manuale di linguistica piuttosto malmesso su cui Rubik scriveva i titoli che aveva appreso prima della nostra fuga e che riteneva potessero tornarle utili. C’era sempre qualcuno che la sfotteva per quello che credevano essere un gioco, tipo una caccia al tesoro.
Rubik rimaneva seria, concentratissima sul suo lavoro.
Forse era pazza anche lei, come Sevil, credevano entrambi di poterci salvare e entrambi rimanevano focalizzati a lungo sui loro pensieri. Oppure si annoiava tremendamente.
Io mi sarei annoiata a stare ferma, chiusa in un luogo tutto il giorno, per questo non vedevo l’ora di poter uscire e quando non si poteva vagavo alla ricerca di mansioni da accollarmi: bucato, divisione degli alimenti e dei rifiuti. Non c’erano bambini a cui insegnare il cucito o l’uso del martello per appendere i quadri. Non c’erano nemmeno quadri da appendere. Quindi me ne salivo sulla terrazza con il mio binocolo e osservavo quegli esseri mostruosi che prima erano i nostri vicini, compagni, amici e parenti. Un pomeriggio vidi la sorella di Rubik. La riconobbi perché aveva gli stessi ricci: era accovacciata a defecare vicino a un cassonetto davanti a La Brocca, mentre qualche cliente abituale che era riuscito a ritrovare il locale, guidato dalla voce del gestore, faceva tintinnare il proprio boccale sbandando tra un tavolo e l’altro. Sestrie aveva le palpebre viola dallo sforzo, rigide e gonfie le rivestivano gli occhi facendo sì che assomigliassero più a un paio di labbra. O di canotti. Le tempie erano gonfie e verdognole e i capillari sembrava dovessero esploderle. Tutta la faccia tirata in un ghigno. Non sapeva che io la stessi osservando. Se lo avesse scoperto si sarebbe sentita umiliata. A Rubik non dissi nulla.
Spostai il binocolo a sud, al limite del canneto, dove lo spettacolo si faceva brutalmente più macabro: uomini che correvano nudi come scimmie a caccia della loro preda, uomo o donna anch’essa.
“Il senno è negli occhi” mi diceva mia madre e io ora non facevo che pensarci. Lei sarebbe andata d’accordo con Sevil e pure mio padre. Avrebbero voluto che io fossi più fedele alle sue regole ma potevo farci poco: ormai non c’erano più. Erano due settimane che controllavo e forse si erano sbranati a vicenda e forse i loro corpi erano stati divorati dai gabbiani che ogni tanto si appollaiavano sulla recinzione che separava la Terra Bianca dal resto. Riposi il binocolo nella custodia e scesi in cappella per la riunione settimanale. Fuori cominciava a fare buio. Mi fiondai lungo la navata centrale presa da un certo fervore, immaginando che se fossi entrata nel confessionale avrei rivelato tutto quanto l’orrido che fino a quel momento avevo silenziosamente incamerato, facendomi carico della violenza del nostro genere e della fine che ne stava conseguendo.
Gli altri avevano rinunciato a vedere: la prima volta gli era bastata a colmargli le interiora di un dolore macabro e pasciuto, che io sentivo invece il bisogno di nutrire. Per questo ero l’unica a salire sulla terrazza e visto che non c’erano state conseguenze, Sevil mi lasciava fare. Rubik diceva che prima o poi mi sarei cucita gli occhi anch’io pur di smettere, ma sino ad allora era un commento che avevo preso a ridere. Quella sera, invece, sentivo nell’aria uno strano presagio e dentro le viscere un mostro da liberare. Serrai le labbra e buttai giù tutto come un pesante bolo indigeribile e mi misi a sedere in prima fila. Sevil parlava dal leggio, e anche noi potevamo parlare se c’era qualcosa che non andava o problemi nella routine. Diedi uno sguardo veloce dietro di me per verificare che fossimo tutti e mi accorsi che Sergio e Tonia, i gemelli, erano in ritardo. Uno, tre, sei, dieci. Sorrisi a Rubik. Mancavano solo loro due, avremmo dovuto aspettarli ma Sevil suonò la campanella di inizio. Mi girai di nuovo verso Rubik chiedendole spiegazioni con lo sguardo, ma rispose con la stessa espressione interrogativa. Sevil aspettò che l’atmosfera di perplessità svanisse e che ci concentrassimo sulla sua figura, poi cominciò: “Sergio e Tonia non ci sono più”.
Mormorio.
“È la prima volta che alla nostra comunità accade di perdere dei membri. Ne siamo tutti addolorati”. Heleen, la responsabile della conta alimenti, che sedeva dal lato opposto, provò ad alzarsi in piedi in segno di protesta ma Sevil la anticipò con un gesto della mano. Indossava una vestaglia di seta nera che non gli avevo mai visto addosso. Qualcuno dietro di me doveva aver alzato la mano, perché le labbra di Sevil si schiusero e la sua voce riempì le volte di un tono calmo e rassicurante.
“Prego”.
“Sono morti?”. La risposta ci stupì più della domanda e del fatto che ad averla posta fosse stata Rubik. Per noi altri era ovvio, eppure ci sbagliavamo.
“Sono oltre la Terra Bianca?”, continuò. Sevil non fece in tempo ad annuire che Rubik era di nuovo all’attacco, come se se le fosse preparate: “Ce li hai mandati tu?”.
Sevil lasciò cadere la domanda nel religioso silenzio della cappella, macchiato solo dai sospiri e dal tremolio di una delle panche, scossa a sua volta dalla paura di alcuni per la risposta che sarebbe seguita.
“Non potevano stare qui” disse infine. “Forse dovreste vedere più spesso cosa succede fuori da qui” mentre diceva questo posava gli occhi su di me. “Li hai visti?”, mi chiese.
Scossi la testa, felice che finalmente se ne potesse parlare. Back, il più grosso e vecchio di tutti, anche di Sevil, domandò cosa fosse successo, ma quella era la domanda a cui nessuno di noi poteva rispondere. Erano cinque settimane che seguivamo varie piste e grazie alla conoscenza di Sevil avevamo formulato due teorie e, a quel punto, la pioggia di colla era da scartare. Restava la chimica: ma allora perché loro sì e noi no?
La settimana successiva ci eravamo dimezzati. Heleen continuava a razionare gli alimenti inserendo nella conta anche Vanja, Kal, Milo, Terri e Gia, allora bisognava inventarsi una scusa, mandarla a lavare i panni, ad esempio, per distrarla e rifare tutto da capo senza turbarla. Gia assomigliava tantissimo a suo figlio: da quando erano morti aveva cominciato a chiedermi di controllare la sua famiglia, io la invitai a guardare con i suoi occhi, perché faceva capire tante cose, ma lei si rifiutò come se le avessi chiesto di uccidermi. Era troppo buona per entrambe le cose.
Nel frattempo, era chiaro che circolava un’epidemia e che presto ci avrebbe fatto fuori tutti. Quello che ci preoccupava era il paradigma secondo cui venivamo addormentati e rigettati nel mondo. Io e Rubik passavamo le serate nei rispettivi letti a chiederci quando sarebbe accaduto e se saremmo morte insieme.
“Sei spaventata?” fece la sera dopo la scomparsa di Terri e Gia, che erano compagni di stanza. Sarebbe potuto capitare a noi due, a Heleen e Back o a Sevil. O prima a Heleen e Back e poi a noi e a Sevil, invece Rubik scomparve insieme a Heleen e Back e io rimasi sola per tre giorni con Sevil, la schiena curva, piegata dall’angoscia della domanda che mi martellava il cervello e come un picchio col suo tronco non mi lasciava in pace: quando sarebbe accaduto di nuovo?
Ormai dormivo da sola. La maggior parte delle volte mangiavo anche da sola. L’esistenza in Terra Bianca era diventata un cumulo di vuoti e solitudine difficili da riempire. Sevil si faceva vedere raramente, trascorreva tutto il tempo nelle camere buie, dove io non potevo accedere, che erano praticamente le sale operatorie. Lì diceva che teneva la Macchina, ma io non potevo vederla. La piccionaia era chiusa a chiave, e le porte erano cinte da una grossa catena metallica.
Il pomeriggio del terzo giorno ne approfittai per andare a fare un bagno, forse l’ultimo. Dalla superficie si vedevano benissimo la sabbia scura, le alghe che vi si depositavano e ogni tanto persino qualche granchio che sbucava da segreti nascondigli. Io me ne stavo a pancia in su come un morto. Immaginavo di essere morta, prima le sensazioni del morire e poi la morte vera e propria, il trambusto della putrefazione mascherato da un’indecente immobilità. Ma la morte non è immaginabile, cosa ancora più tremenda la consapevolezza di diventare cieca prima ancora di essere divorata da un cannibale.
O magari sarei diventata io una dei cannibali. Il capo dei cannibali. Se fossi morta prima di Sevil: altrimenti chi mi avrebbe portato oltre il canneto? Forse a quel punto avrei mangiato Sevil, o Sevil avrebbe mangiato me. Lasciai i pensieri alle onde e tornai dentro a lavarmi l’odore di mare. Mentre uscivo dal bagno delle donne vidi che qualcosa era cambiato. Le luci del corridoio erano accese, fino ad allora non lo erano mai state; Sevil diceva che non bisognava sprecare quello che poteva essere conservato.
Mi precipitai sulle scale quando mi ritrovai a sbattere contro la figura sbiecamente annerita di Sevil. Avevo ancora i capelli bagnati e gli occhi lucidi per via del sale. Era sul pianerottolo, mi aveva vista scendere e per questo si era fermato, ma mi stava venendo a cercare.
“Buonasera, Cam”. Un brivido mi percorse lungo la schiena: non sapevo se si trattasse dell’acqua che colava dai capelli o di timore.
“Buonasera Sevil”.
“Seguimi, per favore”.
Arrivammo all’ingresso del corridoio delle sale operatorie, sempre sbarrato, ma ora la catena cadeva penzolante ai lati della porta di sicurezza. Spalancò uno dei due lati e indicò la terza porta a sinistra. Eccola lì, la stanza della Macchina, pensai: quando entrammo, però, c’era solo un lettino con a fianco un serbatoio di attrezzi chirurgici. Di colpo ero stesa a pancia in su, come in acqua, ma con una mascherina sulla faccia e Sevil sopra di me che balbettava uno, due, tre. Conta, è per farti addormentare e poi, al risveglio, più nulla.
Qualche ora dopo Sevil mi prendeva la mano e, inaspettatamente, ci addentravamo insieme nel canneto, abbandonando per sempre la Terra Bianca.