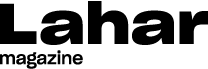Due milioni di anni fa ero una scimmia e non bevevo caffè. Ora se non ne sento l’odore entro dieci minuti dal mio risveglio, rischio di cadere in uno stato catalettico prolungato, un’emicrania potentissima e – ahimè – la stitichezza più ostinata. Ed è tutta colpa di un qualche omino yemenita che un bel giorno, seicento anni or sono, si inventò di utilizzare una bacca africana per risolvere i suoi problemi di sonnolenza. Un grosso autogol per il sud del mondo, col senno di poi. Ora il corno d’Africa e dintorni, le zone storiche di produzione dei chicchi magici, sono tra i paesi più poveri al mondo, con aspettative di vita che si aggirano intorno ai 47 anni. Come tutti i prodotti di consumo mondializzati, la filiera del caffè è dominata dai grandi gruppi industriali che in 20 controllano più del 75% del mercato. Con un simile potere d’acquisto si può fare il bello e cattivo tempo per i contadini degli altopiani abissini; decidere che possano sopravvivere o emettere la loro condanna a morte.
Un esempio pratico (tratto da Raj Patel, I padroni del cibo, Feltrinelli 2007, Milano): le bacche di caffè raccolte da un agricoltore ugandese, al momento della vendita al mulino, gli rendono 14 centesimi al chilo quando per la semplice sopravvivenza ne servirebbero almeno 34. Il povero agricoltore vorrebbe cambiare mestiere, ma non c’è altro da fare per lui su terre come quelle. Sicché, stritolato dai debiti con le banche, cerca di produrre più caffè possibile, incrementando l’eccedenza globale di 900 milioni di chili, distruggendo aree boschive protette e cercando di morire di fame più lentamente possibile. Intanto il caffè è arrivato al mulino al costo di 19 centesimi e viene macinato per altri 5, il minimo per tenere aperto un impianto di macinazione. Dopo che raggiunge la capitale, attraverso spedizioni e mediatori, viene venduto e inviato a Londra, dove esiste un grosso stabilimento Nestlè; il nostro caffè è arrivato ora a costare 1 dollaro e 64 al chilo. Ma è qui che succede la magia perché una volta passato per le mani delle multinazionali il caffè raggiunge i 26,4 dollari al chilo, ovvero 200 volte il costo in Uganda! Con utili simili si potrebbe tranquillamente pagare di più i produttori, ma perché farlo dopotutto? Stiamo parlando di aziende private, votate all’accumulazione di capitale, non alla beneficenza; e la regola sempre valida è “compra a poco, vendi caro”.
Difficile spiegarselo con la logica. Eppure questa è la prassi, una storia tra mille, il normale funzionamento del nostro mondo di libero mercato e capitalismo. Scommetto che ad essere tentata di riarrampicarsi sugli alberi e tornare ad essere scimmie che non bevono caffè, invece di morire sui campi per farlo bere a noi, è la maggior parte del mondo. Peccato che non sia la parte che conta. C’é da capire se la colpa è davvero dell’omino yemenita o di Adam Smith, quel tizio inglese che convinse tutti a fidarsi della mano invisibile dell’economia.
di Tobia Munari