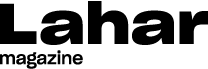Nati con la camicia
Ieri si è rivelata l’ennesima. Sono preoccupata.
Era un pomeriggio piovoso della fine di un mese che non regala novità, tutt’altro: novembre.
E la mia giovane collega di lavoro, nonché collega di studi – lei è in un altro corso, ma per chi non conosce la materia non esistono differenze abbastanza interessanti per ricordarle quando si identifica una persona -, ha un altro lavoro. Come me. E studia. Come me.
La domanda di rito è: “Ma ce la fa? Ma come fa?”, “Cioè studia e lavora?”
Ma ha tempo? Che ritmi sopporta?
Ormai non stupisce più, è da mesi che non scopro negli sguardi di chi incontra queste giovani persone lo stupore di fresche vite all’estremo. Che si spremono.
Sono affascinanti perché si muovono, vorticano e non le vedi. Si affannano e sembra trovino gioia nel farlo affannosamente. Sono consce del frenetico movimento della loro vita e consapevoli che essa sia una condizione ineludibile.
Mettono in campo tutte se stesse senza remore né sensi di colpe né invidie verso altri che hanno la fortuna di non dover lavorare per necessità. Perché non hanno tempo neanche per invidiare, hanno solo il tempo di rimboccarsi le maniche.
Siamo in sette, solo nella mia cerchia di conoscenze; ma ne vedo ovunque, e non solo donne, anche ragazzi che la mattina arrivano assonnati con i calzini spaiati a lezione, il ciuffo un po’ sbilenco e la camicia spiegazzata e il pomeriggio li trovi con un cappellino arancione e marrone in testa che ti consegnano le patatine fritte nel fast-food vicino la stazione.
Oggi i fast-food sono diventati vegan, e fanno i soldi, ma si nutrono sempre di quei giovani stacanovisti che credono ancora nel valore dell’università e non credono troppo in quello del soldo: pronti a guadagnarselo con turni che non permettono loro neanche di frequentare le ore di lezione che pagano.
Hai una frequenza obbligatoria? La paghi lo stesso prezzo dell’ora di lavoro che passi in bar a servire clienti non tuoi: guadagni quei sette euro che ti servono per pagare la lezione che non puoi frequentare perché lavori.
Sono ovunque questi giovani. Invisibili, perché troppo veloci.
Li riconosci perché critichi la loro camicia non stirata o il loro capello un po’ unto, la giacca aperta e le scarpe. Sempre le stesse. Sempre gli stessi pull-over e poca ricercatezza nel vestiario. Perché non hanno il tempo di pensarlo: per loro il tempo è sezionato sul tavolo dell’anatomopatologo: “poco ne hai, tanto ne devi ricavare”.
Il carpe diem si trasforma in quel colpo di spazzola che è meglio non fare perché ti fa perdere la metro; il pensare al calzino giusto ti fa timbrare il maledetto cartellino quel minuto importantissimo dopo. E perdi in un soffio mezz’ora di lavoro.
E così finisci per non stirarti neanche le camicie, perché devi iniziare la tesi. E quel maledetto esame non lo riesci a passare perché il professore ha preso come un affronto personale il fatto che non hai frequentato.
Non spreca tempo a chiederti perché. A entrare in relazione con te.
Non sei abbastanza importante per chiedere udienza al dio del tempo.
La mattina in bicicletta, nella grande città che vive sulle due ruote, Padova, incontri molti volti. E li giudichi per come ti appaiono. Ci sono molti volti che in questo decennio, più che in passato, s’incontrano più volte nella giornata: sono gli sguardi luminosi della generazione di studenti-doppio lavoratori che finiscono gli studi in tempo ma che non guardano con arroganza a chi il tempo per studiare l’ha avuto, e anziché mettersi la divisa ed entrare in turno può tirare fuori il borsellino e girarsi una cicca davanti l’aula studio.
Sono anime che guardano con presa di consapevolezza la strada che li ha condotti a quella fermata… per cercare all’orizzonte il prossimo bus da prendere.
Più volte gli stessi volti, sempre affannati, di corsa, ma sempre con la luce negli occhi di chi si muove alla ricerca di qualcosa, per qualcosa; sempre con il fiato corto ma con una lunga lista di cose da fare; sempre con poco tempo ma molto per le persone che li comprendono e che li sanno aspettare.
Nel ventunesimo secolo il mondo è diviso in due parti: chi ha tutto e non ha bisogno di correre, ma che se anche cominciasse a farlo non saprebbe dove andare, e coloro che corrono perché devono, il cui poco tempo ha chiesto loro di essere decisi sul treno da prendere, per non lasciarselo scappare.
Ragazzi con più ostacoli, e con più voglia di vivere, una vita che però è una parete rocciosa.
Loro sono pronti a mettersi le scarpette per la scalata, come dei cavalli pazzi che corrono fino a perdere il fiato..fino a perdere se stessi senza rendersene conto.
Sono le generazioni di ventenni e trentenni nati negli anni ’90 nelle case di operai medio borghesi, cresciuti dalle nonne mentre i genitori erano al lavoro nelle “nuove fabbriche” che li hanno lasciati a casa ai primi colpi di tosse della crisi.
Per le nonne erano considerati “nati con la camicia”.
Però adesso quella camicia non hanno il tempo di stirarsela perché sono troppo intenti a tenerla stretta addosso.