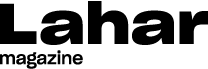-A-
Disteso in disparte, ovviamente. Apatico, incongruente, solo ed unicamente represso. Sguardo assente, forse a causa delle percosse a cui lo abbiamo sottoposto durante il sequestro, sdraiato su un banco da lavoro di acciaio lucido, trattenuto, mentre stiamo finendo di immobilizzare gli arti con dei morsetti a vite, girandoli ben bene per serrarli contro spasmi e un’eventuale fuga. Il soggetto inizia a gridare per la vite che preme e quasi si conficca in ogni suo muscolo e osso e Dio se esistessi quante grane ti darei. Proboscide, lo chiamano così dalle elementari per l’obbrobrioso immenso naso che è lungo e grosso e torvo, che poi lui adesso per giustificarsi si è tatuato sul bicipite un elefante, con la proboscide appunto, che si prolunga sull’avambraccio, prende la spilla da balia dal suo naso, la sfila, schiaffeggia il soggetto e gli tiene ferma la testa, prendendolo per la mascella e la infila sverginandogli il naso, stile septum. Continua così anche sulle orecchie, una per una tutte le spille che Proboscide riesce e reperire dal suo corpo, o dalla sua tuta. Il soggetto in questione urla ancora di più; quindi altre sberle. Il soggetto in questione è il vice amministratore delegato della più nota azienda automobilistica nazionale e lo abbiamo rapito la sera scorsa dopo averlo pedinato per tutto il giorno, aspettando il momento propizio, mentre usciva da un ristorante dove aveva appena concluso una cena di lavoro. Gli abbiamo già strappato le maniche nere dal completo Armani gessato, ma poi abbiamo deciso di spogliarlo, per facilitarci il lavoro, lasciandolo nudo come un animale, lui, mozzarella del cazzo che piange e frigna e suda, anche se gli escrementi non piangono, né frignano, né sudano. La merda. Ci implora di lasciarlo stare, di liberarlo, che non dirà nulla, cerca di dimenarsi, ma dopo un po’ smette perché le viti dei morsetti lo mortificano ad ogni movimento, mentre il sangue gli cola dal naso come moccolo mestruale o escrezione di ragade in esplosione per incontinenze erotiche giapponesi. Che povera fighetta!
Sproloqui ed evasioni reali, scambi oculari di cui potrei fare semplicemente a meno, ma di questo non ho voglia. Ci dice che ci pagherà se lo lasciamo andare, ma a che pro penso io? Per chi ci ha preso? Noi non ne abbiamo bisogno. Lo guardo piangere e lo asciugo con la cravatta con cui è stato rapito. Porpora, scuro, o forse è solo il colore del sangue che risplende saturo in questa atmosfera bluastra. Uno sputo, esploso dalle mie labbra, gli colpisce il viso; così, dopo aver lasciato il muco giallastro scivolare per un po’ sui suoi zigomi malconci, lo asciugo di nuovo.
Tiro fuori la forbice smussata. Non ricordo la prima volta che l’ho utilizzata. Forse era la prima volta che ho tagliato qualcosa, forse no, ma non penso. La memoria è una cosa così fallace. L’uomo perirà quando gli verrà a mancare la memoria, vangando inutile nell’indisciplina storica che lo guida cieca. Ah, che gran troione!
Senza disquisire inutilmente, queste forbici le ho utilizzate per la prima volta l’anno scorso, il giorno della festa della Liberazione del nostro paese dalla dittatura che lo soggiogava, perché morte al fascio, morte alla democrazia imposta. Viva, viva e viva al mondo anarchico!
Bisogna distruggere per poter costruire.
Bonificare per poter vivere.
Insomma, stavo raccontando di come ho utilizzato le forbici, eppure mi sovviene la voglia di prolungare la storia, solo per sentire che non sono solo, eppure. Eppure. Chiacchiere. Chiacchiere inutili, mentre ritagliavo con le forbici la bandiera sfregiandola per poi passarla con la bomboletta spray nera fino a formare nel centro una A cerchiata. L’ho esposta con orgoglio, quel giorno.
Non ho mai pensato in senso nazionalistico, anzi, neppure di familiarità compatriota. Estranei, come il resto del mondo. Extraterrestri di fronte al mio vivere. Eppure, eppure adesso nella nostra grande utopia. Anarchia. Che brutta parola del resto “utopia”, come fosse irrealizzabile miraggio politico. È sogno, sogno concreto, basta indottrinare e volere. Il mondo deve imparare, nel dolore, perché non c’è nascita senza il dolore del parto. Ma c’è anche merda, oh sì, tanta merda che non s’immagina. Porcherie, solo porcherie e bellezza e lacrime di gioia.
Siamo in tre qui sotto, in questa cantina, tra strascichi e stralci di pezzi di quest’anno, e di quelli addietro, che ci risuonano nella testa in un soverchiante effetto Larsen dato dalla contrapposizione, tra crudezza e maestosità, delle azioni che stiamo per compiere.
«Eiaculazione di un orgasmo disperato
Germinato sui rifiuti del consumo siamo noi
Siamo quei pensieri e desideri insoddisfatti
Che tu cerchi invano di inghiottire e di dimenticare
Ma gorgogliano vivi, ti tornano alla mente
Incrinano i valori in cui credevi da sempre
Gelido sudore di una notte senza sonno
Con l’angoscia di un domani sempre uguale siamo noi»
Siamo in tre qui sotto, nella cantina della mia casa, lasciatami in eredità da mia madre che è morta due anni fa, appena pochi mesi dopo mio padre: si è lasciata semplicemente andare, si sono tanto amati. I miei compagni abitano ancora con i genitori, dopo ventisette anni, ma non posso fargliene una colpa. Siamo in cassa integrazione da qualche anno, tutti e tre, lavoravamo presso la stessa ditta, avevamo studiato nella stesse scuole, sin dalle elementari fino all’Istituto Professionale Statale di Meccanica in Via Novara nella Barriera di Milano, stessa compagnia anche dopo, i contatti si sono mantenuti. Infine lo stesso lavoro, poi la stessa sfiga del cazzo. Da un giorno all’altro, siamo anche scesi in piazza a protestare con gli altri, pacificamente, ma non è cambiato nulla. Bisogna applicare la legge della spranga se si vuole farsi sentire.
Colletti bianchi e blu, sempre colletti inamidati dall’insozzatura di muco e sputo e sudore, tutine sfanculate da ceti in picchetto per casse integrazioni d’anima. Quando il lavoro è dovere dato e non diritto, quindi imposizione nella conseguenza del potere di decidere chi può sopravvivere socialmente e chi deve sentirsi una merda.
La nuvola dell’impiegato torna comunque sempre a sorvolarci. Perennemente.
Proboscide, il Cioch e io. Amici, che hanno lo stesso taglio di capelli, rasati ai lati con lo spike, e si vestono allo stesso modo, anfibi e pantaloni e maglie e camicie di flanella strappati e piene di spille addobbati con catene; e compagni, ora. Compagni nella trascuratezza di unghie sporche e nere che dovrebbero essere tagliate e nella lordura di capelli oleati dalle sporcizia e dal grasso cutaneo e dalla punta dei Dr. Martens colorata con le bombolette, ma scolorite dall’acido gastrico delle sbruffate. Figli e frutti del dolore e della indifferenza della società.
Cioch, l’ubriaco in dialetto, chiamato così perché quando beve lo fa fino a perdere i sensi e stramazzare al suolo, prende una lattina di birra, la alza come a voler brindare e se la schiaffa tutta in un sorso, ruttando alla fine, gettando la carcassa vuota insieme alle altre, sulla montagnetta che abbiamo edificato in un angolo della stanza da ieri sera. Beviamo birra per ingannare il tutto, soprattutto il nostro sistema nervoso esausto, tra visioni stroboscopiche mancate e distanze apparentemente appianate e conati convulsi di vomito per toglierci un amaro in bocca così intenso da aver bisogno dell’acido gastrico. Siamo tutti sullo stessa barca malconcia, naupatici inabili al nuoto che vengono spinti al largo barcollanti, in un mare mosso di maleodorante merda.
«Non pensare a domani
Quanto ti sveglierai
Scoprirai che era tutto
Una cazzata
E una lametta taglia troppo in fretta
Non pensare a domani»
Ho ancora le forbici in mano, ma decido di optare per qualcosa di più affilato, così apro i cassetti del banco da lavoro ed estraggo un taglierino, controllandone l’affilatura della lama. Perfetta. Inizio visionando il cranio del soggetto, mentre Proboscide e Cioch glielo tengono immobilizzato, per poi passare ad incidere dei mezzi cerchi sul cuoio capelluto. L’uomo urla, strepita, come se ci importasse qualcosa. Passo la lama con forza, sentendo delle piccole frizioni che sfrigolano come carta strappata con decisione. Gli strappo via i due pezzi di scalpo, lasciandogli una bellissima cresta che col suo precedente taglio da pezzo grosso comunque fa il suo bell’effetto, ci sputo sopra e mi aiuto con il sangue dalle parti, per modellarlo e farla stare dritta, riuscendoci dopo qualche tentativo. Il soggetto è svenuto per il dolore e lo shock e tra noi partono delle risatine nervose o sadiche o che sia quando dico che è meglio così, almeno avrà il tempo di asciugarsi.
«Gioventù bruciata non è soltanto un film
Gioventù bruciata è rabbia e veleno
Gioventù bruciata da vizi e da giochi
Gioventù bruciata vive nella merda
Gioventù bruciata non smette mai di urlare
Gioventù bruciata è sangue sulla strada»
Trovo altri taglierini nel cassetto del banco, così li passo agli altri e iniziamo, un arto a testa, ad incidere la carne per arrivare all’osso, lungo tutta la loro lunghezza per poi poter esporre bene la struttura ossea con dei tagli romboidali. Io prenderò le due braccia, Proboscide la gamba destra e Cioch quella sinistra. “Probabilmente, non si sveglierà più, almeno non avremo più rottura di coglioni” faccio. Non ho risposte, la dedizione al progetto è troppo e la concentrazione è massima.
Vedo la lama infilzare e penetrare la cute attraverso tutti i suoi strati. Lenta, voglio vedere bene. Il maiale si è ingrassato bene col nostro sangue. Recidere carne, grasso, tessuto connettivo, vene e arterie quando le becco, finché si ferma all’improvviso. Sono arrivato all’osso. Ho inciso solo dieci centimetri del braccio destro eppure c’è già così tanto sangue. Guardo gli altri e siamo sommersi dal sangue che fiotta inarrestabile dalle arterie troncate che zampillano a fontana. Nessuno pare farci caso e io non voglio essere da meno. Continuo il mio lavoro. Spoglio il bicipite fino al gomito e sento dei rantolii. Alzo lo sguardo e il cazzone è sveglio; gli altri non se ne sono accorti così, in solitaria, prendo il primo cacciavite a stella che mi viene in mano dal sottobanco, mi dirigo verso la testa e glielo pianto con forza nella tempia. Il soggetto inizia a tremare con spasmi da pollo decapitato, tentando di contorcersi ma non riuscendoci, sempre grazie ai meravigliosi morsetti, sputando sangue e rigurgiti di bestemmie trattenute e maledizioni. Mentre i suoi occhi lacrimano, i miei luccicano compiaciuti. Gli altri mi seguono sogghignando e borbottando “Sgozza il maiale”. Non è una brutta idea, mi dico, così ascolto il consiglio, lasciando la sua testa penzolare all’indietro, fuori dall’estremità del banco a spurgarsi e sgrondare.
«Ti usano per i loro fottuti progetti
Sei solo il loro strumento per raggiungere il potere
Schiavo del sistema
Ti usano e poi non conti più niente»
Continuiamo a tagliare gli arti, dopo averli liberati dai morsetti. Tanto adesso non ce n’è più bisogno. Le braccia e le gambe dopo una buona mezz’ora hanno dei bei tagli profondi; avendo asportato la carne in eccesso sono diventate proprio delle voragini vaginali e lo scheletro si vede nitidamente. Prendo il flessimetro e misuro la lunghezza delle ossa, prima dal collo del femore fino al tarso, per poi passare alla testa dell’omero fino alla fine dell’ulna e radio, urlando gli esiti tra un sorso di birra, aperta insieme ai ragazzi per festeggiare l’avvenuta incisione, e l’altro.
«Ordini leggi restrizioni doveri
Questa è la tua vita se ti rassegni ad obbedire
Chi ha deciso che loro devono governarmi
Perché devono limitare la mia libertà
Io rifiuto tutto questo io rifiuto questo sistema
Io rifiuto il loro ordine io voglio Anarchia, pace, libertà»
Cioch e Proboscide, avvalendosi di un altro flessimetro, una guida tagliatubi e un seghetto per il metallo, cominciano a sezionare pezzi di un lungo tubo d’acciaio delle stesse misure da me dettate, mentre io aspetto in silenzio, osservando il soffitto scrostato e zeppo di muffa muschiosa e verdognola, bevendo e facendo gargarismi con la birra.
(Errico Malatesta è il Profeta)
La rivoluzione/distruzione dello Stato è un atto di pura volontà.
Le masse non diventeranno anarchiche dal nulla: bisogna educarle, indottrinandole e adattandole poco alla volta. La violenza è triste, ma necessaria. L’azione anarchica ha due momenti principali: la distruzione violenta degli ostacoli della libertà e la successiva diffusione della pratica della libertà, priva di ogni coercizione. La violenza è necessaria alla meta anarchica solo, ed unicamente, nella prima parte, quella negativa. Bisogna procedere distruggendo prima l’economia, perché l’interesse, come anche i sindacati del resto, è sempre conservatore e solo l’ideale è prettamente rivoluzionario. Ognuno ha la propria verità e di conseguenza la propria Anarchia, che non deve essere assoluta, ma influenzata dalla solidarietà e dall’amore verso gli altri. Ma ora no, adesso serve un segno al mondo, soprattutto qui da noi. La massa deve essere svegliata dal torpore dilagante dato dall’intrattenimento mediatico consumistico. Vogliamo la rivoluzione e la vogliamo ora!
Anarchia è ordine senza potere.
Questo adesso incido sul petto del soggetto, dopo aver ripreso il taglierino in mano. Verwirrung. Confusione. Questo vogliamo, mentre la mia mano si muove libera e con una volontà propria, come quella di un pittore; distruzione. Noi siamo distruttori perché questo ci sentiamo di fare.
«Se il sistema ti reprime
Usa i mezzi più sleali
Ma la gente si è stufata
Torneremo nelle strade»
Ferrari, Pininfarina e il calcio. Il Toro, il Toro, il Toro! Tutto va a puttane, ma l’importante è poter andare a vedere il Toro allo stadio Olimpico “Grande Torino”. Io preferirei vedere una corrida, mentre sventola lentamente un bel capote nero col Toro pieno di banderillas sul collo così da potergli infliggere, dopo averlo debitamente stancato, lasciandolo ansimante ad agonizzare, il finale colpo di grazia con un fendente di estoque de descabellar tra le scapole, dritta al suo arrogante cuore pesudo-sportivo capitalista, per poi castrarlo e mostrare i suoi testicoli, ora inutili, al pubblico. Questo vorrei vedere e sarebbe uno spettacolo coi contro-coglioni.
Torino.
Immagini di colori slavati e poco definiti, opalescenti ed eterei si stagliano fuori da questa cantina; anche se il sole splende, i raggi solari vengono imbrigliati e offuscati dal fumo delle ciminiere della periferia in una moltitudine di Polaroid mosse. Modaioli variopinti, mode su mode su stili che ciclicamente si ripetono all’infinito in un uroboro monetario che tenta ogni volta di apparire originale. Paghi per essere unico, compri indebitandoti l’unicità e la singolarità di un bellissimo pollockiano sgracchio d’arlecchino pieno di fronzoli e buon gusto. Schiavi eccessivamente super-accessoriati con Superga e guanti senza dita e leggings in pelle attillatissimi e collane improbabilmente enormi e baschi colmi di spille e tintarella auto-abbronzata e capelli cotonati e laccati e tinteggiati e incerati e scolpiti in un attraente visino di vacuità interiore con Wayfarer opacissimi per coprire il tutto perché si sa che gli occhi sono lo specchio dell’anima. Classismo esasperato esasperante. Anche se colori uno stronzo fumante d’oro e lo decori con rubini, diamanti e platino, resta pur sempre uno stronzo fumante.
Torino.
Tra lenzuola e tovaglie colorate stese sulle terrazze degli appartamenti, stipati l’uno accanto all’altro in immensi condomini di piccole api operaie in questo depresso stakanovista alveare, tentano di dare armonia al cinereo resto, ma è inutile, anche se le sempre-gravide regine si ingrassano lo stesso in una oligarchia monarchica di sfruttamento abituale e di meritocrazia illusoria. La città che mi circonda è una città fantasma, senza una reale essenza. Mole Antonelliana, Borgh Vanchija, basiliche, duomi, borghi medievali, musei e santuari, parchi e palazzi e piazze. Piazza San Carlo e Piazza Castello. “Un’altra Italia nelle bandiere dei lavoratori”, slogan propagandistici di speranza. Che tristezza. Una storia compressa e impregnata da una perenne cappa di fumo industriale e dalle perenni impalcature di ristrutturazione che, come coscientemente sappiamo, non termineranno mai e saranno poi coperte per sempre e soffocate lentamente con i loro teli di nylon aerofobi, mentre tutto cade, tutto cade a pezzi, ma nel modo sbagliato. E alla fine il Lingotto. Oh sì, il Lingotto, da sede del mero mercato salariale mercenario a moderna opera d’arte che, come il diavolo, ti chiede la vita in cambio di un lavoro. Tutto è vuoto, fatuo e stolto, l’abitudine e gli agi percepiti hanno imprigionato il popolo in programmate vite in cui tutti seguono azioni che confluiscono in un finale e agognato timbro al cartellino. Ci hanno tolto il senso di vivere.
«Io non sento più ragioni
Me ne frego di parlarne
Odio tutti voi e quelli come voi
Non pensiate che io scherzi, se non è successo prima
Chiamate il 113 che l’ora è già vicina
È ora, è ora, è ora, è ora, ora!»
Proboscide e Cioch hanno finito di tagliare i tubi, quindi vengono verso di me e me li portano risvegliandomi dal letargo dei pensieri. Cerco di sfilare collo e testa delle ossa per poi rimuoverle e poterci infilare le parti tubolari, cosicché la nostra marionetta/mascotte/esempio-per-tutti sia pronta. Sostituisco, con un po’ di sana forza bruta, le parti, che se ne escono con un viscoso e greve schiocco, mentre gli altri mi scrutano in silenzio, bevendo. Finito il tutto, la struttura del pseudo-scheletro è alquanto pericolante, e penso che sia strano visto che avevo preso bene tutte le misure.
Efferatezza sempre maggiore, meccaniche di gruppo tra distruttori che vogliono e bramano la distruzione, uno più dell’altro e via via così, sempre di più, per portare a compimento il nostro scopo, distruggere.
Mi folgora quindi l’idea, così estraggo il cacciavite dalla tempia sinistra e lo pianto direttamente su quella destra, estraendolo poi anch’esso. Rimesto nei cassetti del banco e trovo due frese a gradini con taglienti elicoidali. Le inserisco nei fori praticati col cacciavite. Ora il diavolo, il Toro taurino, è quasi completo. Afferro le forbici smussate, quelle di prima, e recido il pene moscio e morto del soggetto. Agguanto, sempre nel cassetto, una fresa a gradini semplice e la infilo nell’uretra stretta e sonnolente. Gli altri esplodono in una fragorosa risata.
“Sì, è perfetto! semplicemente perfetto!”.
Ridiamo tutti insieme, ciondolando mezzi ubriachi e strisciando gli anfibi nel sangue, circondati da mura fredde e insalubri e rumori, provocati dal nostro caracollare nella pozzanghera sotto i nostri piedi, come di meste masticazioni di noia ad una cena di famiglia.
“Saldiamo tutto con il mastice e siamo a posto”, dico. Cauterizzazioni come saldature classiste, penso.
L’idea comunque adesso è di portare il nostro anticristo nel loro tempio, il Lingotto, e di immolarlo e innalzarlo, legandolo ad un lampione di fronte all’edificio, cosicché sia di esempio e che tutti possano vedere a quali pazzie porta il capitalismo. Un simbolo, un Toro, un diavolo, l’emblema di una società allo sbando. Arte decadente di un mondo in putrefazione o l’ultimo urlo d’aiuto di una generazione che credendosi matura seccamente imbocca la malattia venerea.
Usciamo trasportando il corpo, dopo aver lasciato asciugare il mastice, e Cioch inizia a vomitarmi sulle pareti delle scale.
“Dai, che cazzo, però! Sta attento!”, ma non ricevo nessuna risposta, sembra assente. Non si asciuga nemmeno il moccolo di rigurgito che gli ciondola dal mento.
Dopo aver caricato il corpo nel furgone di Proboscide, ci spogliamo dalle tute di lavoro zuppe di sangue e ci cambiamo le scarpe. Vedo qualcosa nei loro sguardi. Forse è paura? Disgusto? O solo la sbronza che sta scendendo?
Ecco quel tarlo di perplessità che si instaura nella mia mente. Forse l’utopia imposta come moda è costruzione senza fondamenta, tutto è destinato a crollarti addosso, lasciandoti solo, ad annaspare, sanguinante, tra le macerie. La concretezza, alla fine, brutalizza, deflorando per sempre, l’infanzia.
Ci ripetiamo che bisogna distruggere per poter creare, e noi il primo passo lo abbiamo fatto. Ma adesso che cazzo facciamo?
Accendiamo il motore e partiamo, senza dire una parola.
«Guarda nei miei occhi, c’è odio
Guarda nei miei occhi, c’è paura
Senti il mio respiro affannoso
Cerca di ricordarti un sorriso
La mia mente vaga, cerca sempre un posto
Dove riposarsi, è nervosa, non ce la fa più
Non può rimanere qui…»