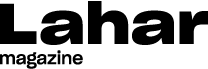Non è un corpo, né un’ anima, né un’ idea.
Quando la cerchiamo possiamo ascoltarla nel suono di una voce intima, nella danza del pulviscolo che taglia come una lama la luce della stanza, o in una pianta isolata sulla cima di una collina mentre ci invita ad appoggiarci a lei, a chiudere gli occhi sotto la sua chioma. Io molte volte la trovai seduta sui marciapiedi mentre stringeva il suo piccolo strumento a piedi scalzi, mentre soffiava dentro un palloncino nero che di lì a poco avrebbe fatto volare sopra i tetti della città; la vidi inoltre nascosta ad ogni angolo di muro dietro il mio cammino, mentre cercava di spiare inosservata il tragitto del mio viaggio.
A volta mi fece pure inciampare sulle radici che sporgevano dal cemento, tanto da meritarsi ogni mia irrefrenabile maledizione. Mi fece precipitare a terra con le mie ossa fragili mentre si serviva della mia innocenza, e non ancora contenta mi sfregiò il volto come segno di avvertenza, e una volta guarita mi trascinò fino alla fanghiglia salmastra della palude per rincorrere inutilmente il volo di una libellula. Mi guidò lo sguardo lungo il cielo per mostrami dove sedessero le sue stelle preferite, e da quel giorno le pleiadi divennero mie sorelle. Mi portò poi nei sentieri del bosco al calar del sole, dove l’acustica ti si avvolge addosso mentre allo stesso tempo si sviscera nell’umidità dell’aria, e lì ascoltammo la melodia delle metamorfosi, strette una all’altra, come madre e figlia nel silenzio freddo prima della notte.
Mi portò a guidare sola lungo la strada senza una meta, forse solo per gioco, forse per regalarmi ancora un altro gioco, quello negato nell’infanzia. Mi incatenò con lo sguardo a fissare le mie paure e con il corpo a sciogliere le sue, di paure, ed insieme forse l’esorcismo riuscì. Si spinse a farmi viaggiare verso l’arcipelago delle farfalle, dove ogni immutabilità è morta e tutto quello che ancor si muove si ostina al violento scontro con ciò che vive d’incertezza. Ha cercato di allontanarmi da lei a calci che avevano la forma di strani volti sconosciuti a cui diede il compito di criticare le mie battaglie, ma anche lì non riuscì a sfuggirmi perché la smascherai prima che lei se lo aspettasse. Più io diventavo abile nel riconoscerla dietro ogni sua scenografia, più ella perdeva drasticamente la sua capacità di mimetismo, e più indietreggiava nella chiazza che il buio aveva disegnato accanto ai suoi piedi; o forse ella era immobile ed era invece quella macchia ad espandersi fino ad inglobare le sue ginocchia.
Ma il buio non può più far paura. Infinite prove ha deciso di superare per riportarmi alla mia casa, lì si è trascinata con il corpo trafitto di frecce dopo aver sconfitto nemici tanto potenti da indossare il camice di primi cittadini, pance rigonfie di velluto unto da servire nella tavola imbandita per cena. Si è cucita gli occhi per non vedere il vuoto che aveva attorno e con le mie membra sulle sue spalle ha camminato in equilibrio sospesa su mattoni dipinti di ideogrammi, con cui all’arrivo ha costruito quello che poi è diventato il mio prezioso castello.
Non un solo mattone è fuori posto perché la sua è una cura magistrale, divina ed io quando mi ricordo di questo posso solo lasciarmi andare alle sue carezze che, come d’incanto, sono riuscite a spogliarsi di ogni fredda armatura che graffiava la pelle dell’avversario e lo allontanava ancor prima di poterlo chiamare: figlio mio.