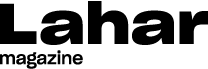Quei ponti fatti di corda, che si stendono tra due rilievi e ti sospendono tra un crepaccio verde, li aveva visti solo nei film. Non che fosse andato troppo lontano a cercarli. Anzi, non li aveva proprio cercati. A quell’età, ancora, le cose ti capitano davanti e le inserisci in un serbatoio di conoscenze e di memoria che funziona, ancora è presto per chiedersi come e quanto, ma funziona. Eppure, in quel sogno, di una consistenza tale per cui sarebbe stato, per i decenni a seguire, in grado di ricreare ogni più piccola particella di foschia di quel paesaggio, vivido, in tonalità sfumate al dettaglio, dove era il colore stesso a tracciare i confini dei corpi, quella singolarità spaziale in tre feroci dimensioni aveva al centro della composizione e dell’azione un ponte di corda, tale e quale ai film, e lui vi si trovava sopra.
Dicono che più brusco sia il risveglio, più il cervello assorba i contorni di un sogno come una macchia sul tappeto. E lui non ricordava, non bene, se il risveglio fosse stato di quelli sussultanti, ansimanti, o se semplicemente avesse aperto gli occhi, lasciando che il reale sfilacciasse piano piano le maglie di ciò che reale era sembrato fino all’attimo prima. Però ancora, dopo dieci anni, scavando nel rimosso non riusciva a ricordare incubi peggiori, e questo nonostante avesse deciso di tagliare del tutto il finale. Era morto, questo era certo, ma non l’aveva visto succedere, e in fondo non era nemmeno quello l’importante. Non era morire l’incubo.
Non era mai stato bravo a disegnare, ma se gli avessero chiesto di ritrarre quel ponte di corda, steso fra quel crepaccio verde, e quel torrente lì diversi piedi più in basso, l’avrebbe restituito con precisione, con tratti decisi; mentre avrebbe di certo sbagliato le proporzioni del giardino del suo condominio, dove aveva passato quasi 17 anni. Si sarebbe scordato qualche dettaglio del viale che girava attorno al quadrato verde in cui aveva massacrato cespugli calciando un pallone di cuoio; il più delle volte passava senza guardare uno spazio che aveva mappato per intero a nascondino, ma che cambiava sotto i suoi occhi sempre più distratti. Ecco, la distrazione. Allora era vero, anche lui lo pensava di se stesso, nonostante avesse appena respinto le accuse di una madre che, davvero, ormai gli stavano troppo strette.
Ci volevano poco meno di due minuti, usciti dal portone del palazzo, ad attraversare il giardino per raggiungere l’auto parcheggiata di fronte a un altro rettangolo verde, più piccolo, troppo piccolo per giocarci a calcio. Due minuti che quel mattino parevano non scorrere. Anche i suoni, i suoni delle 7 e 48 del mattino, erano attutiti come quando nevica, suonavano sordi come se la leggera foschia e il grigio informe dell’atmosfera se li fosse ingoiati. Non piangeva neanche più, non ci riusciva. Sua madre taceva, e questo lo feriva. Perché sua madre, quando era incazzata, non taceva mai. Ma non aveva più ribattuto al suo ultimo disperato “Fosse per me, mi basterebbe il 6 e me ne sbatterei il cazzo”.
Era davvero stato convinto di quella stronzata fino al momento in cui l’aveva detta. Anzi, poco oltre. Quando aveva visto la rabbia del mattino, nel viso di sua madre, inumidirsi fino a spegnersi e diventare qualcosa di molto simile al disinteresse improvviso, aveva cominciato a rimettere in discussione una convinzione che, dalla prima alla quinta, era cresciuta di pari passo alle difficoltà, e all’abbassamento delle sue medie voto perfettine. Sua madre non aveva mai dormito, su quei voti. Ogni volta che il fuoco si sedeva era pronta ad aggiungere un legnetto, sempre più grosso, senza stancarsi mai.
Per questo il rumore attutito dei tacchi di sua madre accanto a lui lo feriva. E in quel mattino grigio, andando verso la macchina, aveva sentito un silenzio inedito per il suo mondo reale. Ma l’aveva riconosciuto dai suoi sogni.
Aggrappato al ponte di corda che cedeva, si era rammaricato di essersi attardato. E la mamma, e il papà, erano già all’altro capo del crepaccio, e lo guardavano immobili. Non paralizzati, immobili.
– Mamma… – sussurrava, perché la voce quando sogni si strozza – Ti prego… –; ma la mamma era lì, in silenzio, con il papà, mentre il ponte collassava sul dorso del crepaccio, portandosi giù il suo bambino.
Non era morire l’incubo.
Si sedette in auto, appoggiando lo zaino fra le proprie ginocchia. Era pentito, voleva chiederle scusa, voleva rimangiarsi tutto, ma sua madre non aveva più parlato e non riusciva a parlare lui una seconda volta. Era come se non potesse farlo. Sbatterono entrambi la portiera dell’auto con un tonfo sordo, e nel chiudere fuori dall’abitacolo il giardino, e i suoni delle 7:50, non percepirono alcuna differenza.