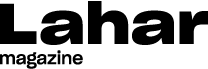I.
«Mi perdoni, Padre, perché ho peccato».
«In nómine Patris et Filii et Spíritus Sancti, Amen. Cosa la turba, figliolo?»
«Ho ucciso un uomo, Padre».
II.
Il cielo sopra Torino era più plumbeo che mai. Spesso si chiedeva se in quelle giornate fredde d’autunno inoltrato il tempo scorresse alla stessa velocità che nelle splendenti giornate di primavera. Come la luce che, con estrema fatica e spesso inutilmente, si faceva spazio tra le spesse coltri grigie sopra la sua testa, anche il tempo in qualche modo sembrava arrancare, pensoso, in quella melma grigiastra.
Non fece in tempo a tirare le somme del suo sterile monologo interiore che eccolo là, possibilmente ancora più livido e cupo del cielo stesso, lo stabilimento Fiat Mirafiori. L’angolo destro della sua bocca si inarcò leggermente in un triste ghigno nel pensare alla crudele ironia di quel nome.
Da quando aveva cominciato a lavorare là, quattro anni prima, non era cambiato nulla; eppure questa volta, e forse era addirittura la prima, rimase attonito davanti alla grandezza dell’edificio che gli si imponeva davanti agli occhi. Il suo elefante nella stanza personale, un’orrenda torre di Babele che si estendeva in larghezza, quasi come se l’aspirare al cielo fosse ormai un simulacro dei tempi andati e l’affronto a Dio si fosse convertito in uno sputo in faccia a tutto il genere umano.
La severità di quell’architettura moderna, scevra da qualsiasi elemento ornamentale, sembrava andare d’amore e d’accordo con la tetraggine di quella giornata e le due, combinate assieme, rendevano la struttura ancora più imponente e minacciosa, tant’è che, fra la nebbia, la sua vista faceva fatica a delimitarne i confini.
Poi, in un istante, cominciò a sprofondare. Dal nulla nel suo cervello si fece avanti l’angosciante sensazione che quello che aveva di fronte a lui non fosse semplicemente un ammasso di cemento, ferro e vetro, ma che fosse un organismo vivente, con un cuore di acciaio e olio, che pulsava con un ritmo frenetico e disturbante.
L’immagine del mostro, che aveva ora perso completamente il suo livello di astrazione precedente ed era diventata così una realtà tangibile, vivida e asfissiante, si impose sempre più prepotentemente nella sua mente mentre guardava gli altri operai farsi inghiottire spontaneamente in quell’inferno sbuffante. Il suo viso impallidì in un secondo, quasi come se il suo cuore, davanti all’ansia e al disgusto che si erano impossessati di lui, si fosse rifiutato di pompare il sangue nel resto del corpo, in un atto di volontà straordinaria che sembrava presagire gli scioperi davanti alla fabbrica di qualche giorno più tardi. Sentì l’aria farsi estremamente pesante e inondargli i polmoni, dandogli paradossalmente una sensazione di soffocamento. La domanda sorse allora spontanea: se quella cosa, quell’enorme accozzaglia di tutto ciò che c’era di negativo al mondo, poteva diventare un qualcosa di vivo, un mostro il cui solo intento era quello di banchettare sui loro corpi, cibandosi del loro sudore, del loro orgoglio e della loro stessa vita, era allora verosimile anche l’esatto contrario? Era forse possibile che quel lavoro alienante, se non la fabbrica stessa, lo avesse privato di quello che lo rendeva umano, trasformandolo in un automa, in una macchina imperfetta fatta di paure e di sconforto?
Qual è la linea di demarcazione che ci rende umani e non un semplice insieme di tessuti, fluidi, organi biologicamente e anatomicamente funzionanti? Come distinguere un uomo da qualcosa che non lo è più? Quanta miseria, disperazione e sudore deve sopportare un uomo prima di essere spogliato della sua umanità? Quanti petali occorre strappare a una rosa prima che essa non sia più tale? Qual è il confine?
Questi pensieri gli diedero un senso improvviso di nausea. Ebbe l’impulso di vomitare, ma riuscì a reprimere quella necessità. Si girò di scatto e cominciò a correre nella direzione contraria, gli occhi sgranati, colmi di una terribile verità. Si era immerso in un abisso, più profondo e più buio dell’inferno, e ora annaspava per ritornare in superficie.
III.
«Ho ucciso un uomo, Padre, perché volevo esserlo anch’io».