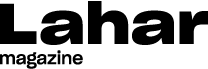Quando la sua mano sfiorò la mia per la prima volta, lo fece con un gesto così delicato che parve una sensazione, priva dell’immediata materialità del contatto. Avvertivo appena i suoi polpastrelli morbidi accarezzare la mia pelle, talmente leggeri da non averne la certezza. Le sue dita lunghe e sottili inserirsi all’interno delle fessure lasciate aperte tra le mie, prima piano, come a chiedere il permesso, poi più decise, con calma precisione, fino in fondo, all’attaccatura. Sentivo il suo palmo appoggiarsi sul dorso della mia mano ad avvolgerlo completamente, una materia più calda che ne incontrava un’altra più fredda, non ero in grado di distinguere la sua temperatura dalla mia, capire a chi appartenesse quale. A quel punto, un brivido mi percorse risalendo attraverso il polso, insinuandosi in parti di me ben più lontane, fino a raggiungere le tempie, provocandomi una paralisi estatica. Deducevo dall’innaturalità della sua postura che anche lei doveva essere scomoda seduta a quel modo, ma entrambe restavamo immobili, mentre alla televisione passava il mio film preferito. Non avrei contratto un muscolo per paura di alterare quel precario idillio innescato dagli impercettibili movimenti delle nostre dita, interromperlo facendone scemare l’intensità. Bruscamente, lei si scostò e con una scusa banale, vedere meglio lo schermo, mi invitò a spostarci sull’altro divano. Apprezzavo la sua intraprendenza, la sua inclinazione al rischio nelle piccole cose del quotidiano, caratteristica che non mi apparteneva. Io ne approfittai per togliermi la giacca, blu come le righe della maglietta che indossavo, proprio lo stesso punto di colore; un abbinamento scelto con cura prima di uscire per quel preliminare pomeriggio in centro. Finito presto, come succede a metà ottobre, sulle sei. Quel precoce tramonto autunnale, di lì a poco, sul rabbuiarsi, rappresentò il pretesto ideale per portarmi da lei. Distese nel suo salotto, ci scambiavamo le prime carezze, incerte e frementi. Sotto il suo peso esile ma consistente, le righe della mia maglietta stretta si dilatavano visibilmente in corrispondenza del petto ad ogni respiro fattosi più ansimante e profondo, sentivo il suo torace respirare contro il mio, nell’aderire plastico dei nostri corpi. Riuscivo a cogliere il suo sguardo nella penombra: i suoi occhi catturavano la luce malferma del proiettore che fendeva la stanza sopra di noi, alterata ad ogni inquadratura dall’azione delle figure e dai cambi di scena. Indugiava spesso sulle mie labbra, si spostava verso il basso, risaliva in cerca del mio, tornava insistentemente ad indicare la mia bocca. Come studiasse la mia figura nella sua interezza per dominarmi tutta con la vista, o semplicemente volesse disorientare la mia lucidità già compromessa. Ad un tratto, mi baciò, quasi all’improvviso, fu come se non me l’aspettassi. I suoi capelli lunghi scivolavano sulle mie guance all’inclinarsi del suo viso, le sue labbra avide sigillavano e schiudevano alternativamente sulle mie l’incastro perfetto. Sul più bello, ci interruppe mio padre, con una telefonata e il suo solito tempismo odioso, di chi è puntuale solo nelle occasioni sbagliate. Mi liquidò sbrigativamente, in poche parole: era arrivato a prendermi e m’incalzava a far presto, con tono seccato e vagamente intimidatorio, “il lavoro”, “è tardi”, non perdendo occasione per manifestare la sua indole stacanovista anche di domenica sera. Mi ricomposi velocemente, raccolsi le mie cose alla rinfusa e con l’aspetto sfatto mi avviai verso la porta insieme con lei. Mi accompagnò alla macchina, parcheggiata nella piazza antistante la chiesa, qualche centinaio di metri da casa sua. Lungo il tragitto mi teneva per mano, mi baciava e mi sorrideva, con l’aria divertita di una bambina che sa di aver appena infranto una regola. E mi faceva sentire così complice.
Quelli erano i primissimi tempi della felicità: le mie giornate si dividevano tra le svogliate lezioni al liceo, le sue cosce a letto e la solita vita a casa. Apparentemente. Ci sono certi contatti di carne, scambi di pensieri, commistioni di esistenze che rappresentano il più elevato dei godimenti umani. Dopo, niente e nessuno è più lo stesso. La mia vita non era più la stessa, io non ero più la stessa. Lei mi aveva dato la possibilità di diventare me stessa: chi ero sempre stata, ma non avevo mai avuto il coraggio di essere.
Una volta, mio padre ci sorprese ad abbracciarci di passione contro il muro nel garage, un trasporto poco fraintendibile con qualcosa di amichevole tra compagne di scuola. Qualche giorno più tardi, aspettò di avermi sotto tiro nel proprio ufficio, impettito con quell’aria solenne e disgustata che gli si leggeva spesso in faccia, sentenziò l’atrocità del mio comportamento contronatura, la necessità di pensare seriamente al futuro, porre le basi per la costruzione di una famiglia cristiana. Infine, concluse con una frase che mi colpì particolarmente: “Ad andar con gli zoppi s’impara a zoppicare”, alludendo alla frequentazione che intrattenevo. Quando me lo disse, testuali parole, pensai all’ironia dell’aver chiamato sua figlia proprio Claudia. Mi domandai, spontaneamente, se fosse consapevole della difettosità intrinseca al mio nome o se si fosse limitato ad una lettura superficiale, ad orecchio, per una scelta tanto incisiva. L’ascoltai, senza dargli retta né risposta, e quando ebbe finito lasciai lo studio, zoppicando.
Avevo sempre pensato che l’amore fosse quel sentimento che porta ad associare una persona speciale alle canzoni più belle che suonano in radio. Invece, provandolo, ho capito che è qualcosa di più. Si tratta dell’illusione che dà loro un senso. Per la prima volta, finalmente, riuscivo a trovarne uno addirittura nei testi dei Verdena; nonostante l’ammissione di insensatezza da parte degli autori stessi. “E anche se non conviene”. Quando si cammina con un’andatura storta, infatti, qualche sguardo altrettanto storto bisogna pur metterlo in conto. Ma il suo, come mi guardava lei, era l’unico di cui m’importasse.