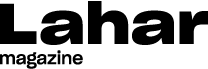Questa luce scomposta che filtra mi ricorda i miei migliori risvegli. Caldo, la sabbia, il soffio rauco in gola, bombardamenti, un sorriso. Sapevo che ne sarei uscito, e ne sarei uscito il meglio possibile, mi dicevo. Lo credevo. Ero alto nel cielo come un’aquila, ero giovane e forte, e tutti si fidavano di me. Stavo incidendo a forza il mio nome nella Storia, quella con la esse maiuscola: tutti, alla fine, si sarebbero dovuti ricordare di me.
Ora questa luce però non si apre per mostrarmi il deserto, né mi spalanca la grigia Germania di cui ho amato molto, tutto forse, tranne il freddo e quei colori, freddo che picchia e che penetra dentro, annulla il fuori. Quel caos spanato di sfumature resta incastrato lì. Ogni mattina prendo gli oggetti riconoscendoli a memoria, per primo il bastone, poi il cappello e gli occhiali da sole. La mano è ferma, anche se sto morendo, e la mia rigidità giovanile si è trasformata in una anziana gravità che non fa chiedere a nessuno, qui, chi sia quell’uomo sulla sdraio, col cappello calato nonostante il caldo. Ho cominciato ad indossare il panama qui, più per necessità che per altro, scettico su come potesse accompagnarsi al mio viso. Ma qualcosa si è plasmato, i miei tratti si son fusi con questo cappello e ora, anche se quei pochi capelli che mi son rimasti sono bianchi e non desterei sospetti a girare a volto scoperto, tengo volentieri in testa questa copertura.
Fisso l’ennesima sfumatura vuota, rossastra. La sdraio galleggia sulla terrazza calda, rivivo i miei brandelli di memoria ringraziando Dio che ogni mattina, all’appello, se ne presentino di meno. Li lascio andare lenti e non so più se a cacciarli sia il rammarico o la mia decomposizione, ma resta il fatto che questo spurgare mi è utile, che è giusto. Ho visto cose orribili con questi occhi ciechi, ho pensato azioni inumane che le mie mani hanno diretto ed eseguito, schiave di un capo che galleggiava in una giovanile idiozia. Tutto era un gioco, un qualcosa che non mi faceva percepire nulla al di fuori di me, come una benda che ti copre. Non avevo ancora questa voglia di ascoltare, né fuori né dentro. Non esiste un modo per bloccare questo, questa macchia è tatuata sulla Terra, questo nome che non mi appartiene più mi ricorda ogni giorno che io sono ancora qui, e devo sbrigarmi a soffrire, terminare questo compito e poi azzerarmi. Il suicidio sarebbe stato da vigliacchi, da irresponsabili.
Il secco di questi giorni velocizza il processo, le strisce salate che conto alla sera sul mio volto sono la differenza tra i ricordi della mattina e quelli di quando mi addormento. Sistematico, metodico: do la caccia a quelle immagini, mi serve la loro pugnalata. Trafitto, li uccido, mi uccido, semplicemente. Questo olocausto finirà, e già lo vedo. L’ultima lacrima cadrà sull’ultima immagine che scompare, e sul mio volto non ci sarà più né dolore né gioia, ma il nulla. Proprio come quando ero giovane. Ed il bastone cadrà, mentre resterò immobile a sputarmi via il respiro. Spero in un giovane, un passante, qualcuno che si accorga, o il mio corpo resterà lì fino a sera, sotto il cappello e gli occhiali da sole.
Sarà poi lo sguardo freddo di uno sconosciuto, a cui apparirò a mia volta come sconosciuto e freddo, a giudicare. E la sentenza sarà a morte, dopo averla scampata così tante volte. Sarà la fine e quel medico, mentre mi porteranno via, ufficializzerà definitivamente il decesso del señor Luiz Fernando Erwin Juan Eugène De La Cruz Y Rommel.