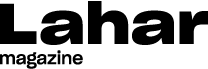Mi alzo, vado in bagno. Piscio osservando la luce del sole scomporsi sul vetro smerigliato. Apro un po’ le imposte: il sole alto si spalma senza pietà sul cemento squartato del marciapiede, piccole nuvole gli scivolano davanti e si addensano nere a ridosso delle montagne, lontane e innocue. Preparo un paio di canne ed esco. Scendo le scale veloce, cammino senza pensare a niente, con foga, puntando la mia meta su ogni fine di strada; non guardo nessuno, calpesto l’asfalto cercando di fargli male, coi polpacci tesi. Non so da quanto cammino, ma non sono affatto stanco, e anzi mi sento rinvigorito. Sono sul ponte: il cielo azzurro si specchia nell’acqua marrone dell’Arno: che schifo, pare il Mekong. Oltre il ponte c’è una processione in costume. Un frate elenca ad alta voce una serie di reliquie che tiene in magazzino: un mignolo di San Tommaso, la punta di una delle frecce che trafissero San Sebastiano, i resti disciolti della ghiandola pineale di Lazzaro; “Liberatevi dall’attrizione, pagate, pagate per avere salva l’anima!”. Un uomo in armatura medievale mi passa davanti sferragliando a ogni passo; emana una luminescenza rossa, come se sul metallo scintillante si specchiasse un tramonto. Si ferma, alza la visiera dell’elmo, si gira per guardarmi. Fuggo prima che mi veda. Sono nella piazza dov’è il pub inglese. Entro, mi siedo da solo a un grande tavolo in legno massiccio il cui ripiano è martoriato di incisioni; una attrae la mia attenzione: alle 3.42 guarda. L’orologio sulla parete segna le 3.42. Mi avvicino alla scritta sul legno, scruto il solco della “g”: una fila di schegge lo delimita, come una palizzata intorno a due canali circolari collegati tra di loro; passo il dito sull’ellisse superiore: le schegge sono una leggera peluria; mi sposto su quella inferiore, mi pungo, mi esce una goccia di sangue, la carne del polpastrello risucchia la scheggia. “Ciao”. La cameriera mi sorride, mi porge una birra, mi chiede se sono l’autore che deve presentare il libro. Sì, sono io. Mi dice che il mio libro l’ha toccata, mi dice che è andato a pescarle qualcosa in fondo all’anima. La guardo: è bella, ha i capelli rossastri e le lentiggini, sembra molto giovane. Già mi conosce, e io conosco lei. Arrossisce e torna verso il bancone. Scolo la birra e mi alzo, non sono affatto nervoso. Nella sala sul retro c’è un sacco di gente seduta su sedie di plastica; non riconosco nessuno: tutti giovanissimi, tutti in austera attesa; alcuni hanno una penna e un bloc-notes, e gli occhialini tondi, e mi fissano bellicosi, mi sfidano. La mia sedia è sul palco, accanto a quella della mia editrice, che indossa un tailleur e si alza per salutarmi con freddezza. Accende sbrigativamente il microfono. “Bagliori non è solo un libro, non è solo un tentativo di elevazione travolto dalle onde della materia, in un tempo che non è tempo, in un luogo che è ogni luogo. Bagliori è soprattutto una testimonianza della verità. Le mie parole non possono rendere quello che questo libro riesce a far risuonare in chi lo legge, quindi lascio la parola all’autore”. Afferro il microfono. Mi alzo. Mi sento stupido e mi risiedo. Grazie a tutti per essere qui. Devo dire… de-vo di…re… che… che l’uni-ca co-sa imp… importante è… è… Si alzano tutti e mi applaudono. La mia editrice mi sorride benevola, mi dà la mano. Importante è avere gli occhi per vedere, perché la verità è davanti a tutti. Non mi sente nessuno. Mi rendo conto di essere ridicolo e inizio a ridere anch’io. Passo tra la gente e ricevo i loro abbracci, le loro parole carezzevoli e di stima. Sono accalorato, quasi commosso da quelle manifestazioni d’affetto. Arrivo al bancone. La cameriera mi guarda un po’ sfacciata. “È stato bello”. Non direi. “Ma sì invece, è stato bello. Quello che fa lei è tutto bello”. Non esageriamo. “Non potrebbe essere altrimenti, lei è Marco Lincei”. “No, non è vero”; c’è un uomo seduto accanto a me, ha i capelli lunghi che gli coprono il volto, di cui scorgo solo il profilo ingobbito del naso; è vestito bene, ma puzza d’immondizia marcita al sole. Guardo nello specchio sulla parete oltre il bancone e lo scopro a fissarmi inespressivo: ha la faccia coperta di croste scure come terra secca e i suoi occhi brillano di un azzurro freddo. Mi volto per cercare il mio stesso sguardo, ma la mia attenzione viene attratta dallo scollo della barista, che non avevo notato prima: bellissime tette. È troppo giovane, devo andarmene, non posso approfittare di lei. “Già, non si può decisamente,” dice il tipo. Mi punto un dito alla tempia e faccio cenno alla cameriera che quello non ci deve essere con la testa. Lei mi fissa con disprezzo. Ci rivedremo presto, dico imbarazzato. Non capisco perché, ma si è messa male. Esco. Ci sono degli americani seduti al tavolo sulla pedana esterna: dicono continuamente cose che devono essere divertenti, perché non fanno altro che scoppiare in risa collettive, e in particolare ce n’è uno che possiede lo spirito più caustico di tutti: ha gli occhiali tondi, il volto efebico e pulito, da icona religiosa, e i capelli biondi perfettamente impomatati in una scriminatura laterale; quando dice qualcosa tutti ridono tranne lui, che al massimo sogghigna o scuote il capo. Sembrano usciti da una sit-com. Noto un piccolo fascio di luce partire da un angolo della pedana e incrociarsi con un altro che arriva dall’alto, e mi accorgo che il capannello è effettivamente l’ologramma di una sit-com. “L’ironia e il sarcasmo vi hanno ucciso l’anima”; l’uomo mi ha seguito. Mi allontano. Devo essere ai margini della zona di Santa Croce, a sinistra si dovrebbe andare per il centro: prendo la destra. È una via stretta tra due fila di muri chiazzati da sudori caliginosi, coi sampietrini in mezzo e un minuscolo marciapiede di bitume nero su un lato; è tanto lunga che non ne intravedo la fine. Mi viene incontro una folta comitiva, li sento pigolare: cinesi. Resto sul marciapiede, li costringo a cedermi il passo, fisso le loro facce annoiate e mi accorgo che hanno tutti lo stesso volto di uomo, anche le donne, e hanno tutti lo stesso identico occhio orbo, il sinistro. Ma quanti cazzo sono? Lascio partire un paio di spallate, con la seconda ne faccio cadere uno. Li supero, e in un ultimo afflato di disprezzo sputo a terra, ma sbaglio e mi sputo su una scarpa. Calcio via la saliva. Entro in un vicolo strettissimo, opprimente. C’è puzza di piscio. I palazzi sono alti e filtra pochissima luce. Provo ad aprire le braccia e riesco a toccare entrambe le pareti: potrebbero stringersi e schiacciarmi. Tiro fuori una canna dalla tasca interna del giubbotto, l’accendo e cammino piano, così da poterla finire prima di uscire sulla strada dalla quale arrivano brandelli di voci e, ogni tanto, accelerazioni di macchine. Credo di dirigermi verso nord, dovrei arrivare in zona stadio a breve. Mi addentro nell’ombra. “Che odorino!”. Mi volto. Un ragazzo mi si è fatto vicino senza che me ne accorgessi: è basso, magrissimo, pelato; ha il viso scialbo, spigoloso; è più o meno mio coetaneo, sui trentasette direi. Mi sorride con quella bocca storta e lo riconosco, il Bamba. Gli chiedo se vuole fare due tiri. Lui accetta poggiando una spalla al muro. Insomma, come va? “Va. Te, invece, ti vedo bene”. È tanto che non ci vediamo. “Non così tanto”. Ha l’aria affranta. Cosa c’è che non va? “C’è un pub dietro l’angolo. I bastardi ubriachi vengono a pisciare qui la sera, quando c’è fila per il bagno: credono che sia una cloaca!”. Annuisco. Ha i denti ammucchiati alla rinfusa e un tic nitido all’occhio destro per cui lo socchiude spesso con un lieve scatto delle palpebre, come se gli ronzasse una mosca davanti. “Io qui ci dormo, cazzo, ci dormo!”. Mi accorgo che è sporco, e puzza di qualcosa di acidulo e ammorbante che mi provoca la nausea. Fa un passo verso di me. Nei suoi occhi risplendono toni vulcanici e dorati. Senti, io vado, ci vediamo un’altra volta. Non ce la faccio a sorridergli. “La finisco io?” chiede, e mi allunga la canna. No dai, fammi fare altri due tiri. Sta guardando oltre il vicolo. “Luce patibolare, malarica,” esclama assorto. Sì. Mi giro, faccio due passi. “Lo senti?” Resto in ascolto. Cosa? “Lo senti?”. Chiudo gli occhi. Sento il frastuono dei motori che passano sul viale, sento i dadi tintinnare sulle giunture, le esplosioni deflagrare negli intestini tubolari, le vampe sibilare nei recessi arrugginiti, gli assi scricchiolare sulla polvere metallica, le tempeste nere mugghiare fuori dagli orifizi incandescenti d’acciaio e ferro; volo basso sull’asfalto, tra le ruote, poi mi alzo in volo e vado lontano, via dalla città, dov’è nero; sento un fischio che sale fino a trafiggermi le tempie, poi diventa un ronzio, poi silenzio. Le scale di pietra alte e strette fiancheggiano l’asfalto, la salita è lunga e ripida. Ogni tanto mi appoggio al muretto a secco che mi corre accanto. Salgo piano, come un geco. Mi sento stanco: è buio, è tardi, l’ora di cena è passata da un pezzo; dovrei tornare a casa. Nella piazzetta polverosa non c’è nessuno, solo un venticello a scuotere i rami di un grande albero nodoso che germina al centro dell’acciottolato e ha l’aspetto di un essere molto antico. Mi volto, mi avvicino alla terrazza. Mi sporgo oltre il parapetto di basalto: la città è ai miei piedi. Chiudo gli occhi e la respiro. Li riapro: le sue luci sembrano le migliaia di occhi di una creatura oceanica, sparsi su tutto il suo corpo geologico che emerge dal mare nero e più fitti al centro, attorno alla cupola e alla torre, al ventre gonfio e al cazzo eretto dell’ermafrodita: il centro è il luogo più irreale, una zona aliena piena di scintillii mondani, di angeli elettrici, di volti fugaci in eterna trasfigurazione; pulsa senza sosta in un alone iridescente, accumula energia cinetica come un muscolo involontario; l’energia viene rilasciata a raggiera fino ai margini della città, esplosa fino al punto in cui si disperde in microparticelle e si annienta. Si annienta qui, dov’è freddo, dove sono io. Qui è reale. Accendo un’ultima canna. La fumo cercando di indovinare casa mia, ma non credo si possa vedere, ingoiata nei pigmenti d’ombra, dove le luci non hanno una sfumatura gialla e calda ma sono bianche e asettiche, disinteressate all’evocazione romantica dell’atmosfera. Alzo gli occhi: un quarto di luna senza stelle, cancellate dalla luminescenza della città. Chiudo gli occhi e li stringo forte: sento il suo odore fresco, le carezzo il culo raggricciato per i brividi, le afferro le natiche bianche da dietro. Riapro gli occhi. La città è ancora lì: mi guarda come si guarda un insetto inutile, neanche fastidioso. Riaccendo la canna. “Documenti, prego”. Mi giro di scatto: uno sbirro, qui, ora. Ho un’ultima canna in tasca: se me la trova sono nella merda; se vanno a casa trovano le piante e mi danno di sicuro lo spaccio: sarebbe la fine: addio film, libri, musica, videogiochi, porno. Sono qui solo per vedere la città. “Cosa sta fumando?” Lo sbirro è giovane, ha la fronte bassa, l’aria ottusa e solenne, le sopracciglia stranamente in ordine, come quelle di una donna. Non è niente, giusto una cosa per rilassarmi un po’. Sento un brivido. “Deve seguirmi in caserma”. Deglutisco a fatica. Ha sentito l’odore del sangue, crede di fare bella figura coi superiori grazie a questa sua escursione nell’agro. Annuisco e infilo una mano in tasca con noncuranza. “Fermo lì!” mi urla protendendosi verso di me. Ruoto su un lato afferrandogli il braccio che mi ha allungato contro e sfrutto il suo slancio per scagliarlo dietro di me: lo faccio con tutta la forza che ho, poi scatto via. Alle mie spalle sento un urlo secco perdere rapidamente d’intensità, un tonfo, poi il silenzio. Mi volto. Lo sbirro non c’è più. Sento il cuore battermi nella trachea. Mi avvicino al parapetto, guardo di sotto. Lo sbirro è incastrato tra due enormi pietre a una quindicina di metri da me, il suo corpo è in una posa innaturale, alla sua testa manca qualcosa. Mi allontano come se qualcuno mi spingesse via. Ho freddo, tiro su il cappuccio. Mi giro. Immobile, ruoto gli occhi per capire se qualcuno abbia assistito: l’ombra nelle vetrate dell’alimentari, le finestre chiuse delle quattro case, la porzione deserta di un vicolo; non vedo nessuno. Dovrei chiamare qualcuno? Sarebbe una cosa da ritardati. Non devo farmi prendere dal panico. Importante è che nessuno mi veda, neanche mentre mi allontano. Chiudo gli occhi: casa, divano. Li riapro e cammino a passo svelto. Arrivo alle scale e rallento: non devo dare nell’occhio. Se qualcuno mi ha visto, però, e ha chiamato gli sbirri? Immagino di essere beccato mentre mi allontano passeggiando. Corro. Il mozzicone: mi blocco. È morto uno sbirro, ci sarà la scientifica, faranno le cose per bene. Devo tornare indietro. Torno indietro. Cammino acquattato. Lo cerco sui massi ampi e grezzi dell’acciottolato. Non lo vedo. Cerco tra le fughe terrose. Eccolo! Calma. Mantengo la testa bassa, cammino deciso, stringo forte il mozzicone in una delle mani che ho cacciato in tasca, faccio alcuni scalini, mi lascio la piazza alle spalle e corro. C’è un oliveto in fondo alla via, in prossimità della curva, oltre il muretto a secco. Mi ci butto dentro. Mi fermo nel buio, prendo fiato, ascolto, non penso a nulla. Non sento sirene, né niente. Se nessuno mi ha visto, sono salvo; se qualcuno mi ha visto anche solo allontanarmi, sono fottuto, non ci vorrà molto per arrivare a me. Vedo la testa esplosa dello sbirro, sento il rumore liquido dell’impatto con la pietra. Vomito. Osservo il fluido acido riflettere la luce argentea in mezzo alle zolle e all’erba. Potrebbero trovarci il dna: lo copro con la terra e resto a fissarlo per capire se ne rimane traccia visibile. La città mi è ostile, non sarei mai dovuto uscire di casa. Alzo gli occhi: i rami non mi permettono di vedere il cielo. Gesù nell’oliveto provò la disperazione dell’uomo. E Dio, cosa gli rispose? Gli rispose? Non importa. Mamma non sarà contenta. Tasto le olive coi polpastrelli: sono piccole e dure. Tra un po’ le saccheggeranno per farci l’olio. Sento il sapore rugginoso del sangue. Il vicolo nero; le mani sul collo di lei; la bocca tappata. Apro gli occhi. Sotto il piumone affogo in una pozza di sudore. Non c’è nessuno, solo io, figlio unico di figli unici morti, a loro volta figli di morti. Resto io a portare il fardello della vita per tutti, sono l’ultimo della staffetta. Mi tiro a sedere, apro uno dei vasi ermetici che tengo sul comodino e prendo una cimetta d’erba appena essiccata. Un guaito randagio sale dalle scale. Billy, il cane di Nonno: è morto subito dopo di lui, quando avevo sei anni. Fino ad allora avevo vissuto nella speranza, anzi ero immune al concetto di cambiamento, vivevo nell’eterno. Nonno viveva qui, biascicava in dialetto, lo ricordo appena. Se non fosse morto, forse sarebbe andata diversamente; se avessi avuto un padre, forse. L’ombra nel vicolo, il puzzo di piscio, le mani sul collo che resiste e cerca di respirare. Le radici non crescono dove è stato sparso il sale. Posso solo sgranocchiare a piccoli morsi la modesta eredità di famiglia; aspetto di seccarmi come una pianta, come Lovecraft. Mi vergogno, e la consapevolezza di vergognarmi mi fa vergognare ancora di più, ma tanto ormai non ho scelta, sono condannato: reclusione a vita, ergastolo autocomminato. Accendo la canna e aspiro due belle boccate acidule. Tengo dentro, conto fino a sette, espiro. Aspiro ancora, conto fino a sette. Chiudo gli occhi. Il professore lesse il mio tema alla classe; applaudirono tutti tranne Bernardi: occhi pieni di paura e disprezzo. Ora è un imprenditore rampante, uno di quei criminali che idolatrano Steve Jobs, soprattutto per idolatrare se stessi. Non mi pubblicheranno mai, nessuno mi conoscerà. Non importa. Eppure vorrei sapere quali strade ho mancato per sprofondare qui, seppellito da tre anni in questa piramide eretta in memoria dei vinti. Troppo sensibile, troppo solitario, troppo timido, troppo senza palle per accettare il fallimento, la delusione, la sconfitta; troppo brutto, decisamente troppo brutto, troppo calvo, troppo basso, orecchie troppo bitorzolute, faccetta troppo da cazzo. Ho perso senza neanche lottare, non avevo le armi; mi sono sentito anche troppo speciale per lottare, troppo superiore: troppo narciso. Non ricordo quando, forse negli anni del liceo, ma a un certo punto il concetto di speranza è divenuto fumoso, inapplicabile, e anche adesso lo comprendo solo in astratto, senza riuscire a declinarlo sulla mia esistenza: è tutto immobile, come quand’ero piccolo, solo che adesso è tutto buio. Poco male, ci sono vite molto peggiori, io almeno ho la libertà di scegliere il mio destino, la mia pena. Afferro con la punta delle dita la canna avanzata, la riaccendo. Lei inerme, con la faccia spiaccicata al muro e la gonna tirata su. Mi diventa duro ogni volta. La castrazione chimica mi renderebbe più libero. Faccio colazione, guardo un paio di puntate e poi ordino la spesa; poi un film, un paio di racconti di Carver, e poi la nottata su The Witcher; un paio di porno, un paio di seghe. Mi alzo, vado in bagno. Piscio osservando la cupezza del mondo esterno premere sul vetro smerigliato. Apro un po’ le imposte: il cielo è coperto di nembi scuri pronti a piovere; sulle grinze delle loro superfici, all’orizzonte, lampeggiano esplosioni elettriche di cui non sento il rumore; il temporale fruscia come un brivido nell’aria. Sul marciapiede, sotto l’alone spettrale del lampione, come un insettoide storpio, si sta avvicinando a fatica uno dei barboni che affollano il vecchio palazzo dei convegni: si trascina dietro tutti i suoi possessi con un carrello, altrimenti gli fotterebbero ogni cosa. Ho letto su internet che tra un po’ li sfolleranno per farci un hotel per studenti fighetti: chiunque si opporrà al progresso verrà manganellato nei reni e nelle palle e trascinato lontano, in una periferia ancora più merdosa da conquistare, da bonificare e, infine, da lasciare in dono agli spocchiosi figli di papà che arriveranno per mangiarci le specialità locali, in cerca di autenticità come dei fantasmi che inseguano i vivi per rubargli un briciolo di calore. Nessuno resta fuori dalla Storia a lungo: lei ti traccia, ti bracca, ti studia e infine ti viene a stanare. Il barbone si ferma, controlla qualcosa nel carrello, alza la testa verso l’alto. Ci guardiamo, solo un attimo. Sento un brivido, non capisco perché. Torna a piegarsi sul carrello. Ci mette un intero minuto a raggiungere l’angolo della strada, quindi segue la svolta del marciapiede e scompare. Chiudo la finestra, sigillo il covo. Mi intravedo allo specchio e subito fuggo lo sguardo. Vado a riprendermi la mezza canna da accendere: me la voglio fumare sul cesso, mentre caco guardando gli highlight di un match Nba. Torno in bagno; inizia a piovere; quasi immediatamente si scatena la tempesta. Resto in piedi ad ascoltarne la foga. Billy era terrorizzato dai temporali, li avvertiva quando erano ancora lontani e allora si infilava sotto al letto: in affanno, con la lingua penzoloni, gli occhi spalancati e le orecchie dritte. Nessuno poteva fare niente per lui, era solo; di fronte alla sua paura, noi smettevamo di esistere. La luce sul soffitto aumenta d’intensità per una frazione di secondo, poi salta; un lampo scintilla sul vetro della finestra; dopo pochi secondi esplode il tuono. L’acqua cade con una violenza deliberata, cattiva: l’ascolto mentre sbava per la voglia di divellere il tetto, sento che vorrebbe trascinarmi via. Un fulmine illumina il bagno ed esplode. Mi avvicino alla finestra, la apro. L’acqua a vento mi sputa addosso le sue gocce grosse e pesanti. Tengo gli occhi aperti. La luce è saltata in tutto il quartiere, è tutto buio. Oltre le case, sulle nuvole basse, si specchiano i bagliori del centro. Il centro è la parte più irreale.